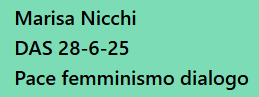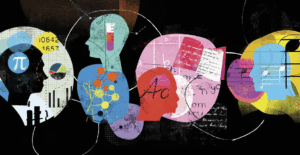Categorie
Bortolon Matteo, Bravo Salvatore, Capitalismo e politica, Capitalismo filantropico, Capitalismo woke, Economia e politica, Filantropia aziendale, Formenti Carlo, Galli Carlo, Ideologia woke, McCracken Andrew, Neoliberismo maturo, Plutocrazia benevola, politiche economiche, Postdemocrazie, Regimi plutocratici, Responsabilità sociale delle aziende, Strategie aziendali
La Redazione
Rhodes, C. Capitalismo woke, 2023
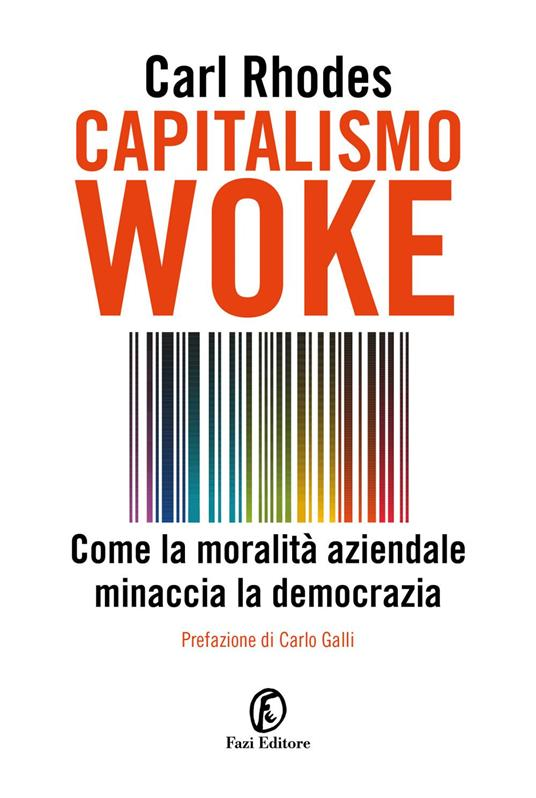
Il report contiene
Indice
Descrizione dell’editore
Prefazione di Carlo Galli
Recensioni:
— Carlo Formenti su Sinistrainrete
— Andrew McCracken su Micromega
— Matteo Bortolon su Sinistrainrete
— Salvatore Bravo su Sinistrainrete
— Michele Blanco su Sinistrainrete
Parole chiave
Bortolon Matteo, Bravo Salvatore, Capitalismo e politica, Capitalismo filantropico, Capitalismo woke, Economia e politica, Filantropia aziendale, Formenti Carlo, Galli Carlo, Ideologia woke, McCracken Andrew, Neoliberismo maturo, Plutocrazia benevola, politiche economiche, Postdemocrazie, Regimi plutocratici, Responsabilità sociale delle aziende, Strategie aziendali
Indice
Prefazione di Carlo Galli
CAPITALISMO WOKE
1. Il problema del capitalismo woke
2. Populisti aziendali
3. Il capovolgimento dell’essere woke
4. Il capitalismo diventa woke
5. Il primato degli azionisti
6. Un lupo in abiti woke
7. Non è verde tutto quel che luccica
8. L’AD attivista
9. La corsa al wokismo
10. Capitalismo razziale/capitalismo woke
11. Il meglio che un’azienda woke può essere
12. La mano destra elargisce
13. Diventare woke nei confronti del capitalismo woke
Note
Ringraziamenti
Descrizione dell’editore
Prefazione di Carlo Galli Dagli spot di Gillette contro la mascolinità tossica ai miliardi di dollari donati da Jeff Bezos, CEO di Amazon, per la lotta al cambiamento climatico, fino alla sponsorizzazione di movimenti di massa come Me Too e Black Lives Matter. Sono sempre di più le grandi aziende che decidono di abbracciare cause politiche tradizionalmente progressiste (diritti civili, sostenibilità ambientale, antirazzismo, giustizia sociale), una tendenza che è stata definita capitalismo “woke”, ovvero sveglio, consapevole. Carl Rhodes ricostruisce la storia di questo importante fenomeno nato alla fine del XX secolo ed esploso nel XXI – dalla responsabilità sociale d’impresa degli anni Cinquanta al neoliberismo degli anni Ottanta, passando per l’appropriazione del termine woke, in origine usato dalla cultura afroamericana, fino ai dibattiti odierni – e discute criticamente che cosa esso significhi per il futuro della democrazia. Esaminando numerosi esempi di strategie aziendali politicamente corrette, Rhodes evidenzia come l’ascesa del capitalismo woke nella vita economica e politica contemporanea abbia conseguenze pericolose. Lungi dal risolvere i problemi della società, l’attivismo di multinazionali che dominano molti aspetti della nostra vita ha effetti antiprogressisti: trasformando la moralità in profitto, esso non solo legittima e consolida un’economia globale in cui miliardari e corporation si accaparrano quote sempre maggiori di ricchezza, ma espande il potere delle imprese a scapito delle istituzioni della democrazia. Come nota Carlo Galli nella prefazione, «il capitalismo woke qui è criticato non perché le campagne che sponsorizza sono sbagliate, o perché fa politica invece che profitti, né perché è poco coerente, ma perché è una funesta degenerazione delle forme politiche occidentali […] manifesta, dandola per ovvia e irreversibile, la fine della distinzione tra politica, società e terzo settore […] L’economia non si limita a invadere l’intera società, ma si sostituisce direttamente allo Stato». Brillante e avvincente, il libro di Rhodes è un testo fondamentale per comprendere uno dei trend politici ed economici più rilevanti dei nostri tempi. «È tempo di abbandonare l’idea che le imprese, in quanto attori principalmente economici, possano in qualche modo aprire la strada politica per un mondo più giusto, equo e sostenibile. Il capitalismo woke è una strategia per mantenere lo status quo economico e politico e per sedare ogni critica. Questo libro è un invito a opporgli resistenza e a non farsi ingannare». Carl Rhodes «Gran bel libro; forte capacità critica, pacata ma radicale; lettura scorrevole e piacevole; testo ricco, informato; argomentazioni acute e ragionevoli, impeccabili, del tutto condivisibili». Carlo Galli, professore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna «Mai prima d’ora l’ambiente di lavoro è stato così politicizzato e le aziende faticano per adattarsi alle richieste dei consumatori e dei dipendenti più giovani… [Capitalismo woke] esamina la storia di questo fenomeno, le cause politiche che ha abbracciato e le implicazioni per tutti noi». «Financial Times» «Carl Rhodes analizza come l’abbraccio calcolato del mondo aziendale alla giustizia sociale rappresenti una seria minaccia per la società. Questo libro non solo svela le ipocrisie e la natura egoistica del capitalismo woke, ma anche il suo effetto nefasto sulla democrazia». «London School of Economics Review of Books»
————————–
Quando le aziende parlano di uguaglianza e giustizia ci si può davvero fidare? Esce oggi un saggio di Carl Rhodes esperto australiano di organizzazione aziendale e del lavoro che risponde a questa domanda, fondamentale per comprendere una delle tendenze più importanti del capitalismo del XXI secolo. Si intitola “Capitalismo Woke. Come la moralità aziendale minaccia la democrazia” ed è edito in Italia da Fazi, arricchito da una prefazione di Carlo Galli.
“Dagli spot di Gillette contro la mascolinità tossica ai miliardi di dollari donati da Jeff Bezos, Ceo di Amazon, per la lotta al cambiamento climatico, fino alla sponsorizzazione di movimenti di massa come Me Too e Black Lives Matter. Sono sempre di più le grandi aziende che decidono di abbracciare cause politiche tradizionalmente progressiste (diritti civili, sostenibilità ambientale, antirazzismo, giustizia sociale), una tendenza che è stata definita capitalismo “woke”, ovvero “sveglio, consapevole”.
“È tempo -sostiene Rhodes- di abbandonare l’idea che le imprese, in quanto attori principalmente economici, possano in qualche modo aprire la strada politica per un mondo più giusto, equo e sostenibile. Il capitalismo “woke” è una strategia per mantenere lo status quo economico e politico e per sedare ogni critica. Questo libro è un invito a opporgli resistenza e a non farsi ingannare”.
Le istituzioni democratiche minacciate dal capitalismo woke
Docente di Teorie dell’organizzazione e preside della Uts Business School presso la University of Technology di Sydney, in Australia, Rhodes studia le dimensioni etiche e democratiche dell’impresa e del lavoro. In questo volume ricostruisce la storia di questo fenomeno, nato alla fine del XX secolo ed esploso nel XXI. Si va pertanto dalla responsabilità sociale d’impresa degli anni Cinquanta al neoliberismo degli anni Ottanta, passando per l’appropriazione del termine “woke”, in origine usato dalla cultura afroamericana, e si arriva fino ai dibattiti odierni, discutendo criticamente che cosa tutto ciò significhi per il futuro della democrazia.
Esaminando numerosi esempi di strategie aziendali ‘politicamente corrette’, Rhodes evidenzia come l’ascesa del capitalismo woke nella vita economica e politica contemporanea abbia conseguenze pericolose. Lungi dal risolvere i problemi della società, l’attivismo di multinazionali che dominano molti aspetti della nostra vita ha effetti antiprogressisti. Trasformando la moralità in profitto, esso non solo legittima e consolida un’economia globale in cui miliardari e corporation si accaparrano quote sempre maggiori di ricchezza, ma espande il potere delle imprese a scapito delle istituzioni della democrazia.
“Gran bel libro -commenta Carlo Galli, docente all’Alma Mater Studiorum di Bologna, che ne cura la prefazione – contiene una forte capacità critica, pacata ma radicale; la lettura è scorrevole e piacevole; il testo ricco, informato; le argomentazioni acute e ragionevoli, impeccabili, del tutto condivisibili”.
I edizione: settembre 2023
© 2022 Bristol University Press
© 2023 Fazi Editore srl
Via Isonzo 42, Roma
Tutti i diritti riservati
Prefazione di Carlo Galli
Gran bella prestazione questa di Carl Rhodes, professore di Studi organizzativi, preside di una Business School a Sidney. Gran bel libro il suo (e anche molto ben tradotto); forte capacità critica, pacata ma radicale; lettura scorrevole e piacevole; testo ricco, informato – grazie al quale anche nella nostra periferia dell’impero si può iniziare a capire qualcosa di un fenomeno importante ma da noi non ancora esploso, appunto il “capitalismo woke” – ; argomentazioni acute e ragionevoli, impeccabili, del tutto condivisibili, a cui non c’è da aggiungere nulla. Eppure, nella sua lineare chiarezza, nella sua esaustiva esemplificazione, la materia del libro è abbastanza complessa. Queste righe sono rivolte appunto a dipanarla.
È una storia di rovesciamenti e di rovesciamenti dei rovesciamenti – il che un tempo l’avrebbe fatta definire “dialettica” – ; di guerre culturali che lacerano una nazione, gli USA (e in generale lo spazio politico anglofono), e che non hanno come pretesto o come posta in palio dei meri simboli, ma una molto reale egemonia sulla società; di una guerra con fronti plurimi, che devono essere ben identificati, perché sia chiaro chi è l’amico e chi il nemico.
Al primo rovesciamento è soggetto il termine “woke”, che nella seconda metà del XX secolo nel gergo delle persone di colore significa ‘sveglio’, ‘consapevole’, ‘critico’: la metafora del risveglio, del resto, è un classico dell’idioma politico – tra gli esempi presentabili c’è il mazziniano «quando un popolo si desta». Ma nel XXI secolo woke muta invece significato e da positivo si fa negativo, derisorio, caricandosi – nel contesto conservatore che lo utilizza – del valore di ‘pseudo – critico, ma in realtà conformista’: woke è il progressista mainstream che ipocritamente ostenta virtù civili per essere alla moda e che conformisticamente si colloca nella parte “giusta” della società, per stigmatizzare gli “altri”.
Ma questo è solo il fronte più largo, il rovesciamento semantico più generale. Il capitalismo woke ha ben altre implicazioni. Derivato dalla filantropia primonovecentesca e dalla “responsabilità sociale delle aziende” degli anni Sessanta, cioè da un impulso del capitale a uscire dalla sfera meramente economica per legittimarsi e per fronteggiare alcuni problemi che esso stesso genera, il capitalismo woke, nato alla fine del XX secolo ed esploso nel XXI (nel mondo anglofono, in prevalenza), cela ben altro. Cela – o meglio, manifesta dandola per ovvia e irreversibile – la fine della distinzione tra politica, società e terzo settore; la società è un unico magma informe, in cui i poteri forti sono quelli delle corporations, non certo quelli politici. È questo lo scenario del neoliberismo maturo, naturalmente, in cui le grandi aziende, i loro AD , danno per scontato che lo Stato abbia fallito nel risolvere determinate questioni sociali e che tocchi all’economia gestirle o direttamente oppure sponsorizzando movimenti politici di massa come, ad esempio, Me Too, Black Lives Matter, o le cause ambientali. Non più quindi i vecchi investimenti culturali nei grandi musei e nelle grandi biblioteche fondate nel Novecento dai “baroni ladri” ritiratisi in pensione, ma nuovi investimenti sociali delle aziende, che vogliono surrogare la politica. L’economia non si limita a invadere l’intera società, ma si sostituisce direttamente allo Stato.
Qui si apre un nuovo fronte complesso: da una parte, l’impegno woke delle aziende è contestato dagli economisti conservatori, a partire da Milton Friedman, sulla base del principio che l’azienda deve produrre valore per gli azionisti e disinteressarsi delle questioni sociopolitiche – come se le antiche distinzioni fossero ancora praticabili e come se fossero state qualcosa di diverso dalla pura ideologia. Meno che mai deve interessarsene se queste producono danni ai bilanci aziendali. A queste critiche se ne aggiungono altre, ancora di parte conservatrice, che mettono l’accento sul fatto che gli AD “democratici” sono in realtà al traino emotivo, se non ne sono apertamente ricattati, dei movimenti politici radical, che sostengono cause futili o pericolose, di stampo eversivo, discriminatorio (nei confronti della “parte sana” della nazione) o socialistoide; o, ancora, che sono davvero woke, ipocriti, perché le loro autentiche prassi aziendali vanno nella direzione opposta dei loro proclami ideologici (anche se questa critica in parte contraddice le altre). In ogni caso, sono dei pessimi capitalisti, destinati al fallimento: get woke, go broke.
Altre critiche, invece, di parte liberal, accusano il capitalismo woke di incoerenza – perché davvero, come emerge da più episodi ricordati nel libro, gli AD woke predicano bene ma razzolano male – e lo esortano a essere ancora più woke, ancora più coerentemente progressista. Se le prime critiche provengono dal fronte opposto, queste provengono dal fronte amico.
La condivisibilissima tesi del libro è ancora diversa e apre un terzo fronte: il capitalismo woke qui è criticato non perché le campagne che sponsorizza sono sbagliate, o perché fa politica invece che profitti, né perché è ipocrita e poco coerente, ma perché è una funesta degenerazione delle forme politiche occidentali; perché non solo l’economia capitalistica travolge società e Stato, distruggendo lo spirito comunitario e producendo disuguaglianze sociali che lo Stato non può affrontare perché le aziende praticano elusioni fiscali di portata stratosferica, che sottraggono risorse cruciali a programmi politici d’intervento nella società, ma soprattutto perché quel capitalismo, col suo nuovo attivismo, opera in due direzioni: l’una – illustrata con esempi celebri e convincenti – di carattere aziendale, perché quell’attivismo è in realtà una tattica di marketing, grazie alla quale le aziende mantengono la presa sugli orientamenti profondi e mutevoli della società e riposizionano il proprio brand in modo da migliorare i bilanci (che questa tattica a volte riesca e a volte no non è un argomento sufficiente per rifiutare questa interpretazione). Nessuna delle cause sponsorizzate, infatti, benché molto spesso ovviamente condivisibili, è (o vuole essere) efficace dal punto di vista della redistribuzione della ricchezza e della limitazione del potere dell’economia, nonché del business aziendale. Sono cause meritevoli sì, ma simboliche o morali, ed economicamente innocue: hanno a che fare con diritti civili, non con diritti sociali strutturali, legati ai rapporti di potere tra capitale e lavoro. Rispetto ai quali funzionano come un diversivo: in ogni caso, l’attivismo aziendale le fa diventare cool, le integra nel discorso mainstream. È questa, del resto, la direzione prevalente delle politiche orientate “a sinistra” in età neoliberista. L’altra direzione in cui si estrinseca l’attivismo woke aziendale è invece strategica ed è quella che più preoccupa l’autore: il quale vi vede un’autolegittimazione del capitalismo che si sostituisce apertamente alla politica perché è impegnato a tentare di risanare, in superficie e non in modo radicale, le contraddizioni che esso stesso crea. Come la lancia di Achille, che da un’estremità feriva e dall’altra risanava, il capitalismo compra tempo – è la sua strategia di fondo, come ha argomentato Stiglitz – : non cerca soluzioni, ma differisce fin che può l’esplosione dei problemi che esso stesso genera. Un cattivo katechon, insomma. Il capitalismo woke è un capitalismo intelligente e sofisticato che, a differenza di quello conservatore antiwoke, si preoccupa del medio termine: e non vuole lasciare spazio a nulla al di fuori di sé, ma vuole dimostrare che solo il capitalismo è il motore della produzione economica, della ricostruzione sociale, della strategia politica. È impegnato in un’opera di neutralizzazione dei conflitti sociali dal valore politico, attraverso mezzi di mobilitazione sociale e morale. Non ha remore né esitazioni nell’inseguire e nel de – radicalizzare ogni richiesta provenga dalla società: l’importante è non lasciare alcuno spazio scoperto, alcuna istanza inascoltata, perché nella lacuna non passino potenze non capitalistiche. Non si deve concedere spazio alla politica, ma se ne deve imitare l’opera, naturalmente senza andare mai fino in fondo – il che significherebbe per l’autore non l’estinzione del capitalismo ma solo che le aziende paghino tutte le imposte dovute, senza elusione; il che significa un rovesciamento dei rapporti di potere oggi in atto tra politica ed economia.
Insomma, se un tempo quello che era buono per la General Motors era buono anche per gli USA , oggi è lo stesso, ma con una mediazione interposta, cioè che la GM – o il suo equivalente digitale – deve sponsorizzare una “buona causa” sia per restare in vita come azienda non superata dai tempi sia per conservare l’ambiente capitalistico neoliberista come l’unico ambiente concepibile, come l’unica società che non ha alternativa. Il capitalismo woke è tanto illuminato e preveggente quanto veramente conservatore: è un’appendice intelligente della plutocrazia; la sua generosità è antidemocratica non solo perché compra tempo ma perché sottrae spazio alla politica. Non è solo ipocrita, quindi, ma è pericoloso: come la vecchia filantropia di Carnegie, vuole rafforzare e legittimare il capitalismo in chiave allora antisocialista e oggi antipopolare e antidemocratica. Ma le strategie aziendali woke non sono solo ipocrite, né sono soltanto diversivi, e neppure realizzano solo la saturazione dell’immaginario sociale: sono la neutralizzazione delle potenzialità politiche implicite nelle contraddizioni sociali e lavorano per la produzione del nuovo uomo a una dimensione, per una nuova integrale mercificazione dell’umano.
A questo livello di analisi Rhodes – che si rifiuta di criticare l’attivismo aziendale sulla base della presunta futilità delle cause che esso sponsorizza, da lui invece ritenute in sé buone – tocca la questione di fondo dei nostri tempi: il posto e il ruolo del capitalismo nella società. E ha perciò senso il suo ultimo rovesciamento, l’esortazione a essere woke. Dove il termine ritrova il suo significato originario di ‘sveglio’, ‘accorto’, un’accezione che in realtà implica l’esercizio della “critica”. Il woke critico contro il woke cool, quindi; il woke consapevole e concreto che si sottrae allo spettacolo e alla mercificazione, e all’autogiustificazione morale e narrativa del capitalismo, non coincide con un azzeccato investimento economico né con la plutocrazia benevola, ma con l’azione politica democratica di una società che si ridesta dal sonno dogmatico, e dagli incubi, del neoliberismo. Un bell’ammonimento, quindi: dall’Australia con rigore.
Recensioni
Carlo Formenti su Sinistrainrete
A proposito del cosiddetto capitalismo woke di Carlo Formenti
Link Carlo Formenti: A proposito del cosiddetto capitalismo woke (sinistrainrete.info)
Testo
Carl Rhodes: Capitalismo woke. Come la moralità aziendale minaccia la democrazia, Fazi Editore, 2023
Leggendo il libro dell’australiano Carl Rhodes, esperto di teorie dell’organizzazione e docente dell’Università di Sidney (Capitalismo woke. Come la moralità aziendale minaccia la democrazia, Fazi editore) è difficile non rendersi conto di un paradosso: scritto con l’intenzione di denunciare i veri obiettivi politici che si nascondono dietro la svolta “progressista” di alcune grandi imprese multinazionali, finisce invece per svelare (sia pure involontariamente) le ragioni per cui la sinistra “politicamente corretta”, con la quale Rhodes si identifica, ha poche chance di contrastare gli obiettivi in questione.
Partiamo dal senso del termine woke, ormai di uso comune nel mondo anglofono ma che non tarderà a diffondersi in un’Europa sempre più “americanizzata”. Coniato dagli afroamericani nel contesto dei movimenti per i diritti civili degli anni Sessanta, e rilanciato nel corso delle mobilitazioni del movimento Black Lives Matter, nato per protestare contro gli assassinii a sangue freddo di cittadini neri ad opera di poliziotti bianchi (sistematicamente impuniti), è stato adottato anche dalle altre componenti della nuova sinistra Usa con il significato di essere attento, sensibile e ben informato rispetto a ogni genere di discriminazione e ingiustizia razziale o sociale (in particolare Rhodes elenca temi come sessismo, razzismo, ambientalismo, diritti LGBTQI+ e disuguaglianza economica, quest’ultima lasciata non a caso per ultima, ma su ciò tornerò più avanti).
Ad adottare questa postura etica, tuttavia, non sono solo i militanti che inalberano le bandiere del politically correct, bensì un numero crescente di grandi marchi multinazionali, i quali non si limitano a sponsorizzare il mondo woke promuovendone obiettivi e slogan attraverso campagne di opinione e/o integrandoli sistematicamente nel linguaggio delle proprie strategie di marketing e pubblicitarie, ma lo sostengono attivamente, sia attraverso consistenti donazioni, sia promuovendo gli ideali woke fra i propri dipendenti (al punto di licenziare chi non vi si adegua). L’interrogativo cui Rhodes cerca di dare risposta nel proprio lavoro è se questa “conversione” non nasconda secondi fini.
L’autore prende le mosse dallo scontro ideologico che la presunta svolta a “sinistra” di manager di colossi come la finanziaria Black Rock, di multimiliardari come Bill Gates e Jeff Bezos, di aziende simbolo della New Economy quali Amazon, Google, Apple, Facebook ecc., per tacere di molti esponenti dello star system hollywoodiano e di grandi campioni sportivi, ha innescato fra progressisti liberal ed esponenti delle destre più reazionarie e retrograde, sia in ambito politico che in ambito giornalistico e religioso. I conservatori accusano i settori capitalistici convertitisi alla retorica del politicamente corretto di essersi accodati agli slogan dei movimenti femministi, LGBTQI+, ambientalisti, pacifisti, antirazzisti ecc. al solo scopo di “ripulire” (greenwashing) la propria immagine, ma soprattutto li accusano di avere così rinnegato il proprio ruolo fondamentale, che consiste nel generare profitti per gli azionisti; li accusano infine di ipocrisia, cioè di simulare idee e sentimenti che non provano realmente, contribuendo in questo modo al dilagare di un moralismo di massa che danneggia i principi e i valori tradizionali del popolo americano.
Curiosamente, quest’ultima accusa che arriva da destra converge con la critica più diffusa da parte delle sinistre. Tipica, in tal senso, la posizione assunta da un’esponente della sinistra democratica come la senatrice Elisabeth Warren, la quale invita le aziende ad essere woke non solo a parole ma anche nei fatti. Non si può essere veramente woke, argomenta la Warren assieme ad altri esponenti della sua parte politica, se l’impegno di manager e imprese si riduce a chiacchiere e a donazioni che, per quanto cospicue, sono poco più che briciole rispetto ai mostruosi profitti realizzati dai soggetti in questione. In particolare, certi slogan sulla giustizia sociale stridono con i mostruosi livelli di disuguaglianza che queste imprese hanno contribuito in prima persona ad alimentare negli ultimi decenni, né sono associate ad azioni concrete per ridurli. In poche parole: il “buonismo” ipocrita delle imprese non apporta cambiamenti reali in seno ai programmi del capitalismo.
Pur condividendo tale osservazione, Rhodes non la considera il nodo centrale delle questioni sollevate dall’ascesa di questo inedito “capitalismo di sinistra”. In primo luogo, sgombra il campo dalle ubbie di coloro che vedono nel fenomeno il rischio di un crollo dei profitti e un grave danno per gli interessi degli azionisti, che manager “plagiati” dalla sinistra sarebbero disposti a sacrificare sull’altare della propaganda liberal progressista. La verità è, argomenta citando una serie di dati in merito, che questa svolta non solo non ha danneggiato gli interessi aziendali ma ha anzi contribuito ad aumentare significativamente i profitti. Insomma: sposare l’ideologia woke sembra un ottimo affare. Ma i veri obiettivi della svolta, argomenta, sono altri e decisamente preoccupanti, nella misura in cui, sostiene, mettono a rischio la sopravvivenza stessa del sistema democratico. Il fatto che le imprese divengano woke, scrive, non potrebbe essere un mezzo per estendere il potere e l’egemonia del capitalismo? Non si tratta di “capitalizzare” la moralità pubblica, in modo che il dibattito civico e il dissenso democratico vengano sostituiti da campagne di marketing e pubbliche relazioni?
Per rispondere, Rhodes affronta la questione dal punto di vista storico. In primo luogo, ricorda che il fenomeno attuale presenta evidenti analogie con quello della filantropia dei robber barons, i rapaci monopolisti che dominarono l’economia americana negli ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi del Novecento. Superata la Grande Crisi del 29 e la parentesi bellica, personaggi come Carnegie e Rockefeller, per citare i più noti, si trovarono negli anni Cinquanta a fronteggiare la sfida dell’alternativa socialista incarnata dall’Unione Sovietica e reagirono investendo una consistente fetta dei loro immensi profitti (Carnegie dispose che, alla sua morte, il 90% del patrimonio che aveva accumulato dovesse essere impiegato in iniziative benefiche di vario tipo). Il loro impegno filantropico era parte di una strategia lucidamente finalizzata a contrastare le possibili tentazioni socialiste da parte dei lavoratori americani. Né si trattava semplicemente di tener buono il popolo con il vecchio trucco di elargirgli panem et circenses: l’obiettivo era assumere il controllo delle politiche pubbliche onde sostituire progressivamente il sistema democratico con una plutocrazia benevola. Ebbene, scrive Rhodes, l’attuale capitalismo woke ripropone la stessa logica, con l’unica differenza che, oggi, a impegnarsi socialmente non sono più (o almeno non sono solo) i singoli magnati ma le aziende stesse. Come si spiega questo ricorso storico?
iIl fatto è che, nel corso del “trentennio dorato” del secondo dopoguerra, un potere politico ispirato ai principi ridistributivi keynesiani aveva favorito un compromesso fra capitale e lavoro che garantiva alti livelli di occupazione, salari decenti e servizi pubblici accessibili ed efficienti nel contesto di un ampio sistema di welfare, contribuendo a neutralizzare i progetti di instaurazione d’un regime plutocratico. La controrivoluzione liberista avviata negli anni Ottanta dai governi Thatcher e Reagan, e successivamente diffusasi in tutto il mondo occidentale, ha sistematicamente smantellato questo dispositivo. Liberalizzazione selvaggia, delocalizzazioni e globalizzazione finanziaria hanno invertito il corso della storia, generando livelli di disuguaglianza ancora più estremi di quelli dell’era dei robber barons, legittimati da narrazioni in merito alle chance di mobilità sociale che il libero mercato offrirebbe a tutti i soggetti dotati di spirito imprenditoriale, e dal mito del “trickle down” (cioè dalla tesi secondo cui una parte dei superprofitti accumulati dalle megaimprese “sgocciolerebbe” fino alla base della piramide sociale, garantendo benessere a tutti).
Queste narrazioni neoliberiste sono naufragate sugli scogli delle crisi del 2000-2001 e 2007-2008 scatenando la rabbia di lavoratori, consumatori ed elettori e aprendo la strada ai movimenti populisti (da notare che Rhodes sembra associare automaticamente al fenomeno populista le forze politiche di destra, ma anche su questo tornerò più avanti). È per fronteggiare la rabbia popolare che nasce il capitalismo woke (“una polizza assicurativa contro lavoratori, consumatori ed elettori esasperati” scrive Rhodes). Appropriandosi dei temi e degli slogan delle sinistre, le grandi imprese tentano di costruirsi delle credenziali etiche per distogliere l’attenzione dalle proprie rapine a danno dei beni pubblici, cui non hanno alcuna intenzione di rinunciare (non a caso, fra le cause che perorano, non viene quasi mai menzionata la lotta alle disuguaglianze di reddito e all’evasione fiscale). Il populismo aziendale è l’altra faccia del populismo di destra: se il secondo difende le ragioni del capitalismo selvaggio, il “progressismo” del primo è ancora più insidioso in quanto rivendica la propria capacità di risolvere problemi che i governi non possono né vogliono più risolvere. L’idea è che, più le imprese si dimostrano in grado di gestire le proprie “responsabilità sociali” meno ci sarà bisogno di intromissioni politiche in campo economico. Le grandi imprese, sostiene Rhodes, costituiscono una nuova élite il cui potere sulla società ambisce a rimpiazzare quello del governo democratico. Se questo obiettivo si realizzasse, si avvererebbe il sogno dei robber barons: il potere politico non sarebbe più la posta dello scontro pubblico fra opinioni contrastanti, bensì del dibattito fra le voci di coloro che detengono il potere economico, l’equilibrio del potere verrebbe quindi irreversibilmente spostato dalla sfera della democrazia alla sfera dell’economia. A questo punto cercherò di spiegare perché ritengo che gli argomenti di Rhodes e della cultura politica della sinistra politicamente corretta di cui questo autore è espressione non hanno alcuna chance di contrastare i fenomeni che il suo libro analizza e denuncia.
* * * *
Parto da una constatazione: il regime plutocratico che Rhodes presenta come un rischio da scongiurare è già da tempo un dato di fatto. Basti considerare che una buona metà dei senatori e deputati che siedono nei due rami del parlamento americano appartengono alla minoranza dei super ricchi. Ciò non è solo dovuto ai costi proibitivi delle campagne elettorali che fanno sì che solo pochi privilegiati possano “comprarsi” un seggio (sia con le proprie risorse personali sia con quelle che vengono loro offerte dalle lobby finanziarie che li sponsorizzano, le quali ne condizioneranno il voto dopo che verranno eletti), ma è anche e soprattutto l’esito di un progressivo processo di integrazione fra élite economiche, politiche, accademiche e mediatiche, ben simboleggiato dal meccanismo delle “porte girevoli” che fa sì che le stesse persone assumano in successione le più alte cariche direttive nelle imprese private, nelle istituzioni pubbliche, nei partiti e nel mondo culturale (università, giornali, tv, ecc.). Questo sistema “truccato” (come è stato definito dall’esponente dell’ala socialista del Partito Democratico Bernie Sanders) non ha più nulla a che vedere con le regole della democrazia, ma è espressione di un regime che autori come Colin Crouch hanno definito post democratico (vedi Colin Crouch, Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari 2013).
Se le cose stanno così, è evidente che nessun ritorno alle politiche socialdemocratiche appare possibile in assenza di radicali sconvolgimenti economici, politici e culturali, senza cioè che si verifichi una vera e propria rivoluzione. I fallimenti dei progetti neo socialisti di Sanders negli Stati Uniti e di Corbyn in Inghilterra dimostrano che queste nuove sinistre non sono all’altezza del compito, non solo perché condizionate dagli apparati delle sinistre tradizionali ormai convertite al credo neoliberista (con le quali i leader appena citati non hanno avuto il coraggio di tagliare i ponti), ma anche perché è fallito il loro tentativo di saldare i movimenti femministi, antirazzisti, LGBTQI+, ambientalisti ecc. con i movimenti dei lavoratori e, per capire le ragioni per cui è fallito, occorre interrogarsi sul perché le classi lavoratrici preferiscono in larga maggioranza votare per i populisti di destra (tutte le ricerche sui flussi elettorali confermano che in tutto l’Occidente a votare per le sinistre sono i membri delle classi medio-alte che abitano nei centri gentrificati delle metropoli, mentre le masse che vivono nelle periferie votano in massa a destra).
Uno dei pochi seri tentativi di rispondere all’interrogativo è quello della coppia di sociologi francesi Boltanski-Chiapello (vedi L. Boltanski, E. Chiapello, Il nuovo spirito del capitalismo, Mimesis, Milano-Udine 2014) i quali, analizzando la scissione fra “critica artistica” e “critica sociale” verificatasi alla fine dei Settanta (la prima concentrata su rivendicazioni dei diritti di specifiche minoranze, di fatto compatibili con il sistema capitalistico e sempre meno attenta a quelle delle classi lavoratrici), hanno ben descritto il nuovo spirito del capitalismo (che altro non è se non il capitalismo woke di cui parla Rhodes). Il merito di questi autori è avere colto le radici di classe del fenomeno: a mano a mano che le classi medie riflessive che erano state protagoniste delle lotte anti autoritarie della fine dei Sessanta e dei primi Settanta entravano a far parte di una rinnovata casta dirigente (nelle imprese, nei media e nelle istituzioni), plasmavano una nuova cultura manageriale “progressista”, ma sostanzialmente compatibile con le regole del sistema. In altre parole: non è che il capitalismo woke abbia manipolato le nuove sinistre o che, al contrario – secondo la narrazione conservatrice – si sia fatto manipolare da esse, si tratta piuttosto della spontanea formazione di un blocco socioculturale che incarna l’illimitata capacità adattiva del capitalismo alle mutate condizioni storiche in cui si trova via via ad operare.
Rhodes è del tutto incapace di cogliere questa realtà perché ancorato a una visione ingenua, irenica, di una democrazia che non è mai realmente esistita, se non come facciata politica di un sistema socioeconomico fondato sullo sfruttamento e sull’oppressione capitalistica della forza lavoro. Per lui il conflitto sociale non è lotta di classe bensì confronto fra opinioni. Così leggiamo, fra le altre cose, che “l’etica può sfidare il sistema stesso su cui poggia il capitalismo”; che non si tratta di condannare l’attività imprenditoriale in sé perché “le imprese possiedono il potenziale per sostenere la democrazia”; che “la politica democratica si fonda sulla convinzione che le persone (cioè gli individui non i popoli!) abbiano il diritto di governarsi da sole”; che “i consumatori detengono il potere della domanda (!!??)”; che, citando Greta Thunberg, “è l’opinione pubblica che governa il mondo libero (!!??); infine che non c’è niente di sbagliato nel fatto che gli attivisti LGBTQI+ si siano rivolti alle aziende per raccogliere consensi, in quanto si tratta di ”un’azione democratica dei cittadini che hanno utilizzato l’influenza delle imprese”.
Il nostro ritiene di essere portatore di una cultura anticapitalista, ma il suo anticapitalismo si riduce in buona sostanza a combattere l’evasione fiscale da parte delle imprese e delle minoranze dei super ricchi. Sembra cioè convinto che, una volta che tali risorse siano state recuperate e messe al servizio del bene pubblico, sarà possibile restaurare il paradiso socialdemocratico (ammesso sia mai realmente esistito). Il guaio è che anche questo programma minimo appare irrealizzabile nel contesto di un capitalismo come quello americano che domina oggi l’intero Occidente (e in particolare le sue propaggini anglofone come quell’Australia di cui Rhodes è cittadino) e che sta lottando con le unghie e i denti contro tutte le nazioni emergenti che ne minacciano l’egemonia. Le nuove sinistre credono che basti vincere le battaglie per il riconoscimento dei diritti delle minoranze che esse rappresentano per minare le basi del sistema, ma è proprio un fenomeno come il capitalismo woke a dissipare simili illusioni: è vero che il capitalismo ha via via saputo sfruttare i conflitti razziali, di genere, etnici e religiosi per dividere i lavoratori e rafforzare la propria egemonia, ma è altrettanto vero che è in grado di sopravvivere anche riconoscendo i diritti di neri, donne, e minoranze varie cooptandone una parte nell’élite.
Un esempio? Le star dello spettacolo e dello sport che “lottano” per gli obiettivi cari a Rhodes godono di retribuzioni di entità scandalosa perché percepiscono una quota dei sovraprofitti capitalistici. Le rivendicazioni di uguaglianza di genere, razza e quant’altro sono tutte realizzabili nel quadro del sistema esistente, purché non mettano in questione l’unica vera rivendicazione incompatibile, vale dire la distribuzione egualitaria del plusvalore prodotto dai lavoratori. In verità non è che Rhodes manchi di porre questo obiettivo, ma lo inserisce nell’elenco al pari di altri, mettendolo cioè sullo stesso piano delle varie rivendicazioni delle sinistre politicamente corrette. Finché non gli verrà invece attribuito il posto d’onore, finché non gli verrà cioè riconosciuto il ruolo di conditio sine qua non per la realizzazione di tutti gli altri, i lavoratori continueranno a lasciarsi sedurre dalla demagogia dei populisti di destra, e a tenersi alla larga dal chiacchiericcio politicamente corretto che percepiscono come un discorso oggettivamente divisivo rispetto agli interessi generali del popolo degli ultimi. In effetti, mentre si indigna per le accuse di autoritarismo che i conservatori rivolgono agli ayatollah del politically correct, Rhodes tace sulle pratiche di certi movimenti (dalla caccia alle streghe scatenata dal movimento MeToo, alla cancel culture che pretende di riscrivere la storia “correggendo” i capolavori del passato accusati di sessismo e razzismo, passando per una serie di paradossali manifestazioni di intolleranza condannate anche dalle più avvedute esponenti del movimento femminista come Nancy Fraser) siano effettivamente autoritarie, intolleranti e cariche di disprezzo nei confronti delle classi inferiori (vedi in proposito J. Friedman, politicamente corretto. Il conformismo culturale come regime, Mimesis, Milano-Udine 2018).
Concludo con un’ultima annotazione critica. Nel lavoro che sto qui discutendo ho trovato ben pochi accenni all’oppressione e allo sfruttamento dell’Occidente capitalistico nei confronti delle altre nazioni. Si aggiunga che, partendo evidentemente dalla convinzione che all’Occidente spetti il monopolio dell’unica vera forma di democrazia, Rhodes non condanna l’arroganza criminale con cui ci auto attribuiamo il diritto di “esportarla” – anche con la violenza – nel resto del mondo, quasi questa pretesa fosse un aspetto marginale della disuguaglianza. Vedi in merito il capitolo in cui esalta la lotta “democratica” dei cittadini di Hong Kong contro il regime “totalitario” di Pechino, senza fare cenno 1) al fatto che Hong Kong è una ex colonia dell’imperialismo inglese da poco restituita alla sovranità cinese; 2) che sfruttando il regime transitorio di questa enclave in attesa della sua piena integrazione nella madre patria, essa viene utilizzata come rifugio per autori di crimini (soprattutto economici) commessi in Cina, nonché come paradiso fiscale di capitali sottratti al controllo della Cina popolare; 3) che serve da base logistica di quei servizi occidentali che alimentano, organizzano e finanziano i movimenti anticinesi perseguendo gli stessi obiettivi di “regime change” che perseguono in tutti gli altri Paesi che si oppongono all’egemonia angloamericana.
Andrew McCracken su Micromega
Capitalismo woke: come la moralità aziendale sta sabotando la democrazia
Link al testo on line https://www.micromega.net/capitalismo-woke/
Testo
In “Woke Capitalism: How Corporate Morality is Sabotaging Democracy”, Carl Rhodes esplora come l’abbraccio calcolato della giustizia sociale da parte del mondo aziendale rappresenti una minaccia significativa per la società.
Andrew McCracken 16 Agosto 2022
Nella stagione 2016 della National Football League, Colin Kaepernick – un quarterback che giocava per i San Francisco 49ers – ha preso posizione rifiutandosi di alzarsi in piedi. In segno di protesta contro l’ingiustizia razziale, Kaepernick ha scelto di sedersi, poi di inginocchiarsi, durante la tradizionale esecuzione dell’inno nazionale, prima di ogni partita.
Questa protesta silenziosa ha toccato un nervo scoperto in un momento in cui gran parte del mondo era ossessionata dalla sconvolgente campagna presidenziale di Donald Trump e dal suo flirtare con il nazionalismo bianco. Sebbene lodato da molti a sinistra, Kaepernick è stato accusato di mancare di rispetto agli Stati Uniti e alle sue truppe ed è stato insultato verbalmente durante le partite. Un importante analista afroamericano lo ha descritto come non veramente “nero” (Kaepernick è birazziale ed è stato adottato da genitori bianchi), mentre lo stesso Trump ha suggerito che “dovrebbe trovare un Paese che funzioni meglio per lui”. La protesta è costata a Kaepernick anche la sua carriera; dopo la conclusione della stagione 2016, il suo contratto non è stato rinnovato e nessun’altra squadra della NFL si è mossa per ingaggiarlo.
Kaepernick ha avuto però un’altra possibilità. È diventato il protagonista della campagna pubblicitaria “Dream Crazy” della Nike, lanciata a settembre 2018 con lo slogan: “Believe in Something. Even if it means sacrificing everything” [“Credi in qualcosa. Anche a costo di sacrificare tutto”]. Costruire un’importante campagna di marketing attorno a una figura così divisiva sembrava un grosso rischio per la Nike. E le reazioni iniziali hanno suggerito che l’azienda avesse fatto male i suoi calcoli: fan di abbigliamento sportivo sconvolti dalla cosa hanno bruciato i prodotti dell’azienda, il prezzo delle azioni è sceso e Trump, a quel punto presidente, ha affermato che la campagna stava inviando “un messaggio terribile”. Ma la Nike sapeva cosa stava facendo. Il prezzo delle azioni è aumentato dopo aver riportato un significativo aumento delle vendite, mentre la campagna stessa ha vinto un Emmy.
Due anni dopo, il New York Times ha rivelato che la Nike era tra le numerose aziende che facevano pressioni per diluire le misure del governo statunitense contro il lavoro forzato nello Xinjiang, la regione cinese che produce il 20% del cotone mondiale. Sui social media, la storia del New York Times è stata beffardamente pubblicata insieme allo slogan della Nike: “Credi in qualcosa. Anche se significa sacrificare tutto”.
La Nike è lungi dall’essere l’unico marchio globale i cui tentativi di cooptare cause “woke” hanno determinato accuse di ipocrisia, ma l’abbraccio calcolato della giustizia sociale da parte del mondo aziendale rappresenta una minaccia sociale più significativa? Nel suo avvincente libro, Woke Capitalism: How Corporate Morality is Sabotaging Democracy (Bristol University Press. 2021), Carl Rhodes, docente alla University of Technology di Sydney, sostiene di sì.
Rhodes fa risalire il “capitalismo woke” al movimento di responsabilità sociale delle imprese emerso in America a metà del XX secolo. Nel 1953, l’economista americano Howard Bowen sostenne che i leader aziendali avrebbero dovuto riconoscere che le loro attività riguardavano non solo i loro azionisti, dipendenti e clienti, ma la società in generale. Per Rhodes, il capitalismo woke rappresenta una boriosa forma della responsabilità sociale d’impresa delineata da Bowen, con molte aziende che oggi cercano di agire – ed essere viste agire – in modo socialmente responsabile in arene che non hanno alcuna relazione con i loro affari.
I critici conservatori del capitalismo woke hanno sostenuto che estendere la responsabilità aziendale al di là degli interessi degli azionisti è un tradimento del principio capitalista. Come ha affermato Milton Friedman: “C’è una sola responsabilità sociale delle imprese: utilizzare le risorse e impegnarsi in attività progettate per aumentare i profitti rimanendo entro le regole del gioco”.
Per Rhodes, questa critica al capitalismo woke rappresenta un fondamentale malinteso del movimento. I capitalisti woke non stanno cercando di capovolgere o reindirizzare il sistema capitalista; stanno lavorando per proteggerlo. Negli anni Cinquanta Bowen sostenne che i tentativi da parte del governo di regolamentare gli affari “potrebbero mettere a repentaglio le nostre libertà essenziali e limitare lo spirito di impresa”. Rhodes evidenzia questo commento come un tradimento della realtà secondo cui la responsabilità aziendale è sempre stata “una tattica difensiva per scongiurare quella che era vista come una vera minaccia del socialismo”. Oggi, molti dei più importanti sostenitori del capitalismo woke affermano che la rabbia popolare per gli impatti negativi delle grandi imprese rappresenta una minaccia esistenziale che deve essere sventata. Il capitalismo woke, come la responsabilità sociale d’impresa prima di esso, consiste nel “garantire che il capitalismo e le disuguaglianze che produce possano sopravvivere senza una rivolta popolare”.
L’interesse personale al cuore del capitalismo woke è rivelato dall’atteggiamento delle aziende nei confronti della tassazione. Sottolineando che il pagamento delle tasse “è la responsabilità sociale delle imprese”, Rhodes mette in evidenza le contraddizioni delle aziende che sostengono cause di sinistra come i diritti lgbtq e Black Lives Matter, mentre si impegnano contemporaneamente in “un’aggressiva elusione fiscale“. Le aziende stanno privando i Paesi di tutto il mondo di miliardi di dollari di entrate fiscali che potrebbero essere investiti in programmi di welfare, mentre si autoproclamano eroine nella lotta per la giustizia sociale.
Come suggerisce il sottotitolo del suo libro, Rhodes si preoccupa non solo delle ipocrisie e della natura egoistica del capitalismo woke, ma anche del suo effetto pernicioso sulla democrazia. Il ceo di BlackRock Larry Fink ha affermato che, poiché i governi non riescono ad affrontare le principali sfide che ora il mondo si trova di fronte, il pubblico “spinge le aziende” a intervenire laddove i politici hanno fallito. Woke Capitalism etichetta questi argomenti come un “assorbimento ostile” del sistema democratico.
La filantropia aziendale è anche indicata come una potenziale minaccia alla democrazia. Nel 2020, il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha impegnato 10 miliardi di dollari per il Bezos Earth Fund, un’organizzazione mirante a limitare e combattere gli effetti dei cambiamenti climatici. L’oscena ricchezza di Bezos – al momento in cui scriviamo, Forbes stima il suo patrimonio netto in 171 miliardi di dollari – è in parte attribuibile al ben documentato sfruttamento delle scappatoie fiscali da parte di Amazon. Rhodes è giustamente critico nei confronti di un sistema che consente ad aziende e individui di privare i governi democraticamente eletti dei fondi per perseguire i loro obiettivi politici. Questo sistema consente agli stessi imprenditori di “determinare il futuro dei cittadini del mondo” incanalando la loro ricchezza in progetti scelti in base “ai loro capricci e alle loro predisposizioni personali”.
Nonostante la sua avversione per il capitalismo woke, Rhodes non è anti-woke. Le campagne “woke” di giustizia sociale sono discusse con ammirazione in tutto il libro, mentre i critici di questi movimenti sono bruscamente liquidati come eccentrici di destra. Parti di Woke Capitalism suggeriscono che Rhodes possieda una sensibilità di sinistra vecchio stile, con i suoi appelli ad aumentare le tasse sulle grandi imprese, rovesciare i colossi aziendali e annullare il neoliberal consensus. Rhodes conclude con l’appello a stare in guardia nei confronti del capitalismo woke e delle iniquità del sistema che cerca di difendere. Resta da vedere se qualche partito politico di sinistra offrirà una visione in grado di realizzare queste riforme.
(traduzione dall’inglese di Ingrid Colanicchia)
* L’articolo è uscito originariamente su LSE Review of Books il 28 aprile 2022 con il titolo “Book Review: Woke Capitalism: How Corporate Morality is Sabotaging Democracy by Carl Rhodes”.
Matteo Bortolon su Sinistrainrete
Il Link Matteo Bortolon: Capitalismo woke (sinistrainrete.info)
Il Testo
Capitalismo woke / di Matteo Bortolon
Carl Rhodes: Capitalismo woke. Come la moralità aziendale minaccia la democrazia, Fazi, 2023
 Il capitalismo è diventato di “sinistra”? Quello che parrebbe un paradosso, più che una provocazione, è un quesito al centro di un testo, (C. Rhodes, Capitalismo woke, Fazi 2023) di estrema attualità, e forse persino anticipatore per quanto riguarda il dibattito italiano ed europeo. Si dedica a un fenomeno tipicamente statunitense, che ancora pare non abbia lambito significativamente il Vecchio Continente, e cioè l’attitudine delle aziende a sostenere cause progressiste quali l’ambiente, le cause LGBT, l’antirazzismo, i diritti delle donne e simili.
Il capitalismo è diventato di “sinistra”? Quello che parrebbe un paradosso, più che una provocazione, è un quesito al centro di un testo, (C. Rhodes, Capitalismo woke, Fazi 2023) di estrema attualità, e forse persino anticipatore per quanto riguarda il dibattito italiano ed europeo. Si dedica a un fenomeno tipicamente statunitense, che ancora pare non abbia lambito significativamente il Vecchio Continente, e cioè l’attitudine delle aziende a sostenere cause progressiste quali l’ambiente, le cause LGBT, l’antirazzismo, i diritti delle donne e simili.
Il libro in poco più di 300 pagine svolte il tema in 13 capitoli, leggibili quasi indipendentemente dal resto; il primo di essi enuncia la questione in termini generali, e ciascuno dei seguenti lo specifica e arricchisce in base a esempi specifici.
L’elemento di riferimento centrale è il termine woke, di cui l’autore fornisce una essenziale ma completa illustrazione: come si descrive nel terzo capitolo (Il capovolgimento dell’essere woke), la parola (che letteralmente significa “risvegliato” o per estensione semantica “consapevole”) nel suo senso politico deriva la sua accezione da un discorso di Martin Luther King e dal milieu del movimento per i diritti dei neri negli Usa, ma è stata resa celebre al di là di tale ambiente dalla cantante soul Erykah Nadu nel 2008, finché il movimento Black Lives Matter l’ha consacrata nel 2013 come parola chiave del progressismo contemporaneo.
Successivamente woke da termine molto connotato in una radicalità sociale (antirazzismo ma anche anticapitalismo, antimperialismo ecc.) ha avuto uno slittamento semantico per designare una attenzione un po’ ipocrita e ostentativa a cause progressiste di moda quali il razzismo, il cambiamento climatico, la parità femminile, e simili.
Alla fine il termine è stato più usato dai suoi detrattori che dai sostenitori, in senso quasi completamente deteriore, indicando una esibizione di virtù morali in tali direzioni, sfociando nella battaglia culturale sul “politicamente corretto”.
Il tema centrale del libro riguarda il fatto che numerose aziende statunitensi (con qualche escursione nel contesto australiano) abbiano abbracciato tali temi e facciano attivismo in tal senso, fornendo una variopinta galleria di esempi: dal ricco CEO di BlackRock che tuona contro l’ingiustizia sociale, allo spot di Nike contro il razzismo; da Gillette (azienda di lamette da barba) che fustiga la “mascolinità tossica”, al sostegno di varie compagnie al referendum australiano del 2017 sul matrimonio omosessuale. Questi non sono esempi isolati: “fra le imprese, soprattutto quelle globali, vi è una tendenza significativa e osservabile a diventare woke” (p. 32), tanto che “secondo il New York Times il capitalismo woke […] è stato il leitmotiv di Davos 2020”.
Com’è ovvio, il favore verso tale attivismo sarà di segno simile all’atteggiamento verso i temi in se stessi: tendenzialmente benevolo nel mondo progressista, e di violento rigetto in quello conservatore. Secondo molti commentatori di destra culturale le aziende sarebbero cadute vittime di una agenda progressista che minerebbe il capitalismo: “le grandi aziende sono diventate il principale tutore culturale della sinistra”; “la sinistra culturale ha conquistato le burocrazie delle aziende americane” (due commentatori citati alle pp 15-16). Oltre alla antipatia per la sostanza stessa di tale agenda, fa capolino l’argomento secondo il quale i dirigenti d’azienda non avrebbero il diritto di far valere un punto di vista valendosi del peso economico che possono esercitare – che si limitassero a fare il loro mestiere senza debordare in politica insomma. Argomento non privo di persuasività, anche se va detto, sia pure per inciso, che questa posizione mostra un discreto livello di ipocrisia: non pare che da quel versante politico si sia mai sollevato grande clamore quando industriali reazionari come i fratelli Koch hanno sostenuto e innaffiato di soldi varie realtà religiose conservatrici, o antiambientaliste afferenti al Partito Repubblicano.
Dato che già il sottotitolo del libro fa intuire la sua posizione assai critica (“Come la moralità aziendale minaccia la democrazia”), occorre specificare che l’autore, l’australiano Carl Rhodes, non è un conservatore o un reazionario. Nella sua pregevole ricapitolazione dello sviluppo di Black Lives Matter (pp. 46-55) ha parole elogiative verso tale movimento, individuandone le radici nelle mobilitazioni degli anni Sessanta di M. L. King, e non risparmia le critiche a chi lo attacca da posizioni identitarie: “per la destra antiwoke la libertà di parola si traduce nella libertà di attaccare chi non è d’accordo con lei.”
Eppure la sua posizione verso il capitalismo woke è altrettanto se non – paradossalmente – più critica e negativa di quelle di segno conservatore.
Fra i detrattori gli argomenti in voga sono sostanzialmente due. Secondo il primo un’azienda ha solo il dovere di fare utili, e non dovrebbe fare moralismo o promuovere una determinata agenda politica – non tanto per l’ingiustizia di approfittarsi del proprio potere economico per far avanzare le proprie opinioni, ma per distogliere energie dal suo scopo primario. Il secondo fa leva sulla strumentalità di tali posizionamenti: sarebbe solo un pretesto per rifarsi l’immagine – il celebre greenwashing sui temi ecologici, per esempio. Naturalmente versioni diverse di queste due linee di attacco si trovano mescolate – l’accusa di ipocrisia e incoerenza in particolare ha sempre una grande efficacia, ed è facile stigmatizzare il VIP che corre col jet privato al vertice contro il riscaldamento climatico.
Sintetizzando, secondo la prima critica i dirigenti woke sarebbero troppo poco capitalisti, anche perché rischiano di fare meno profitti; per la seconda lo sarebbero ma con modalità ingannevoli e incoerenti, usando gli ideali come mero marketing.
La prima obiezione per l’autore è assolutamente da respingere: le aziende che hanno esibito un attivismo woke più accentuato non hanno visto un crollo dei propri utili ma al contrario hanno consolidato se non rafforzato la loro posizione sul mercato. Questo tenendo conto anche del fatto che non si tratta solo di un posizionamento di immagine a costo zero (rilasciare comunicati con le proprie posizioni e mandare i dirigenti a fare dichiarazioni ha un costo nullo ovviamente) ma anche di contributi concreti – parliamo di milioni di dollari per queste cause. Eppure il ritorno di immagine consente non solo di recuperare i costi ma di ampliare gli utili.
Questo ci porta alla seconda critica, che Rhodes analizza andando oltre l’accusa un po’ superficiale di falsità o ipocrisia, ma gettando uno sguardo alla logica interna dell’impresa. Le due modalità di approccio aziendale che esamina sono la responsabilità sociale d’impresa (RSI) e il mecenatismo dei ricchi.
Il primo di questi principi è un richiamo ai dirigenti a considerare nelle proprie decisioni le ricadute su tutti i soggetti (detti stakeholders, “portatori di interessi”) coinvolti. Si dovrà dunque gettare un occhio su consumatori, lavoratori, fornitori, ecc. per includere anche il loro benessere, oltre a quello di proprietari. Questo sembra in contraddizione con la centralità del primato degli azionisti. L’autore mostra come tale nozione – secondo la quale il primo dovere e obiettivo primario dell’azienda è produrre profitti per essi, appunto – serpeggia nella ricerca accademica negli anni Settanta per esplodere nella cultura aziendale nel 1983, conformemente al disegno dei governi neoliberisti di Thatcher e Reagan di costruire ogni individuo come un capitalista. Ma in realtà poiché il fine è di pulire il biasimo che l’impresa attira su di sé perseguendo esclusivamente profitti, la RSI può essere vista non come una attenuazione degli interessi degli azionisti ma come una miglior strategia per la tutela degli stessi a lungo termine, evitando boicottaggi, pubblicità negativa, rivalse legali e simili.
Qualcosa di simile è il mecenatismo filantropico dei ricchi, il cui riferimento principe è Andrew Carnegie e il suo saggio Il vangelo della ricchezza. Si tratta, in questo caso, di usare una certa parte del proprio patrimonio a favore di opere di utilità sociale – soprattutto di carattere culturale, ai tempi del magnate (tipo biblioteche o musei); una sorta di strategia politica per evitare che la recrudescenza della diseguaglianza lasci spazio al socialismo, dando una parvenza di armonia fra ricchi e poveri. Tale forma, se pare abbastanza sorpassata nella sua modalità ottocentesca- primo novecentesca (segnata da un paternalismo abbastanza fuori fase), sopravvive oggi nelle fondazioni foraggiate dall’oligarchia che erogano borse di studio o altri tipi di sovvenzioni; ed è proprio una di queste, la Andrew Mellon Foundation che nell’estate del 2020 ha annunciato una decisa priorità “alla giustizia sociale in tutte le sue forme”.
Entrambe queste forme di “redistribuzione dall’alto”, al di là degli innegabili impatti positivi che sicuramente possono avere sui loro beneficiari diretti, prestano il fianco a critiche sulla loro sincerità o sulla rilevanza sull’insieme della società: i limiti di tali orientamenti saranno logicamente il non poter mettere in discussione la base del profitto, dovendo limitarsi al sentiero stretto della compatibilità con essa.
Simili critiche colpiscono in pari misura il capitalismo woke. E’ facile vedere come fra i temi di tale impegno ci sia una forzosa selezione determinata dagli interessi preminenti: non si è ancora visto le grandi aziende scendere in campo contro l’elusione fiscale, perché sono i primi a praticarla.
Rhodes però non si limita a stigmatizzare una forma di strumentalità o incoerenza, ma nel nucleo forte della sua argomentazione si spinge più lontano. Prima di tutto la considera una forma di sfruttamento ulteriore. Nel capitolo in cui si descrive il posizionamento della National Football League (NFL) contro il razzismo si suggerisce un parallelismo suadente: il 70% dei giocatori della NFL è afroamericano, ma le squadre sono tutte possedute da bianchi; dopo una lunga tradizione di sfruttamento commerciale delle doti fisiche dei neri, adesso avviene la cannibalizzazione delle loro lotte. La NFL, infatti, dopo aver sbattuto fuori importanti giocatori perché per protesta si inginocchiavano anziché cantare l’inno nazionale prima delle competizioni in segno di protesta per la brutalità della polizia, ha introdotto nel luglio 2020 il canto Lift Every Voice and Sing, un brano considerato fra le massime espressioni del radicalismo nero, prima di ogni partita. Simboli e slogan vengono così sfruttati – quando cambia il vento – per rifarsi l’immagine continuando a macinare profitti.
Ma non è solo questo. L’autore, citando l’avvocato costituzionalista John Whitehead (p. 20) vede nel capitalismo woke una modalità con cui le grandi imprese si stanno sostituendo al governo democratico, regredendo a una forma di neofeudalesimo. E lo fanno nel modo seguente: nel contesto in cui l’amministrazione Trump ha mancato di dare risposte convincenti a problemi quali la violenza poliziesca e il controllo sul possesso di armi, esse si sono poste come nuovi “riferimenti morali”. Come afferma, in maniera inquietante, il presidente della Ford Foundation, di fronte agli squilibri sociali “in mezzo alla tempesta la voce più chiara è stata quella delle imprese”. Gli amministratori delegati di General Motors e Wal-Mart si sarebbero “assunti il rischio di dire la verità al potere”.
Alcuni passi citati fanno veramente rabbrividire: esponenti delle più grandi aziende di un paese che è universalmente considerato una corporatocrazia che si appellano alla responsabilità morale di tenere una postura etica di fronte ai mali che affliggono la società. Tutto ciò ricorda la cosiddetta “cattura oligarchica”, il processo in cui il mondo degli affari riesce a controllare le istituzioni nominalmente dedite al bene pubblico per fare i loro interessi. Adesso sono le stesse strutture simboliche emancipative che vengono colonizzate e sfruttate.
Senza contare il fatto che il panorama di sconsolante svuotamento della politica di affrontare i problemi sociali lo hanno in buona sostanza creato le imprese stesse, corrompendone soggetti e prendendo il controllo degli apparati, vampirizzati dalle varie lobby. Proprio in ragione di ciò è sorto il populismo identitario di Trump e di altri suoi simili nel mondo.
L’autore in merito a ciò suggerisce di “diventare woke nei confronti del capitalismo woke”, rifacendosi all’etimologia originaria del termine: essere consapevoli che i guasti sociali non verranno risolti da esso, ma aggravati, perché promosso dagli stessi soggetti che li hanno determinati.
Rimarrebbe da dire quanto tale testo parli agli europei e agli italiani in particolare. Può darsi che tale fenomeno arrivi anche qui, come molte mode da oltre atlantico. Chi scrive non pensa che ciò avverrà, almeno in queste forme, perché il contesto sociale è profondamente diverso e un processo di adattamento sarebbe impegnativo. Ma si deve segnalare che qualcosa del genere è già avviato nel Vecchio Continente: non le imprese diventano direttamente la fonte del verbo moralizzatore, ma gli apparati burocratici diretta espressione delle pressioni lobbistiche e della tecnocrazia: gli organi della Commissione e la BCE. Se si pensa infatti al modo in cui esse si stanno attivando sul tema del cambiamento climatico abbiamo un perfetto esempio di cattura oligarchica di un tema una volta patrimonio di gruppi radicali o anticapitalisti per volgerlo a vantaggio del profitto privato o comunque giocarlo nel letto di procuste di strumenti di mercato. Anche in questo campo il suggerimento di Carl Rhodes a mantenere la barra dritta e non farsi ingannare focalizzando l’attenzione sui problemi sociali reali (p. 267) pare convincente; ma chi scrive direbbe piuttosto: tenere presenti i nodi strutturali, cioè i meccanismi di accumulazione di profitto, di abbassamento dei salari e dell’agenda di privatizzazioni e liberalizzazioni propugnata dalla mannaia della centralità della concorrenza nel diritto europeo che schiaccia il costituzionalismo democratico.
Salvatore Bravo su Sinistrainrete
LINK a Sinistrainrete
Il Testo
Capitalismo woke / di Salvatore Bravo
 Populismo aziendale
Populismo aziendale
Il capitalismo woke è la nuova frontiera del capitale. Le metamorfosi sinuose del capitalismo sono in linea con il nichilismo che lo sostanzia. La capacità di sopravvivere del modo di produzione capitalistico ha la sua ragione profonda nel vuoto metafisico del capitale. L’economia si autofonda, non ha verità sul suo fondo, è causa sui. Tutto è solo valore di scambio: la vita e la morte valgono fin quando producono PIL. Solo in tal modo riusciamo a comprendere la via che sta battendo il capitale: dal 2024 sarà possibile in Canada per i malati psichici chiedere il diritto “alla dolce morte”. Non si investe per sanare gli effetti sulla psiche e sul corpo di un sistema che nega la natura umana e sociale, si incentiva l’autoeliminazione. Coloro che non sono resilienti possono chiedere il diritto alla morte. Nessuna indagine o analisi sulla causa del male di vivere, si procede per “la libera eliminazione degli ultimi”.
Il capitalismo è ateo, poiché non contempla la verità, ma la avversa. L’ateismo del capitalismo è libertà da ogni vincolo veritativo.
Tutto è spettacolo e tutto “deve fare PIL”.
Il capitalismo è assoluto, in quanto ab solutus, sciolto da ogni vincolo etico e da ogni progettualità politica. La comunità non è contemplata, essa è solo “mercato”.
L’ultima frontiera del capitale è Il capitalismo woke (progressista), è dunque la nuova metamorfosi, tale mutazione genetica non cambia la sostanza del capitalismo, anzi ne accentua la pericolosità.
Capitalismo dell’indecenza
Il capitalismo woke è l’arma egemonica contro la politica e, specialmente, contro l’elaborazione di percorsi politici alternativi al capitale. Tale salto qualitativo è reso possibile dal vuoto della politica, ormai dipendente dalla catena di comando dei grandi gruppi economici e dalle multinazionali. Il travestimento del capitalismo in fogge progressiste è anche il sintomo palese del vuoto culturale e politico nella sinistra ufficiale, per cui il workismo può avanzare indisturbato con l’appalauso trasversale della politica e con la tragica ammirazione delle masse che divengono sempre più impotenti e depauperate nello spirito di classe e materialmente.
Si difendono i diritti individuali, si trasformano taluni eventi di cronaca in manifestazione semireligiosa con cui adestrare le masse ai dogmi del capitale. I popoli divengono plebe ubbidiente alla mangiatoia dei diritti individuale e nel contempo gli effetti dei tagli dei diritti sociali sono abilmente oscurati. Le campagne su taluni casi di cronaca che in modo sincronico occuppano ogni spazio mediatico, dimostrano la manipolazione dell’informazione e la sudditanza organizzata dei media al “credo” della religione del capitale.
Il capitalismo woke minaccia la democrazia e quel che ne resta. Taluni esponenti della destra del capitalismo temono che il capitalismo woke possa essere “la fine del capitalismo”, poiché sta assumendo forme socialiste, ma si tratta del gioco delle parti:
“E se invece l’adozione del wokismo da parte delle imprese producesse effetti esattamente opposti a quelli condannati dai critici conservatori? Anziché essere la campana a morto del capitalismo, il fatto che le imprese diventino woke non potrebbe essere piuttosto il mezzo con cui estendere il potere e la portata del capitalismo in modi estremamente problematici? Se così fosse, ed è questa l’idea fondamentale su cui verte il mio libro, il capitalismo woke dovrebbe essere contrastato e combattuto su basi democratiche, poiché esso fa sì che gli interessi politici pubblici vengano sempre più dominati dagli interessi privati del capitale globale. Se seguiamo questa linea di pensiero, i problemi per la democrazia sorgono nel momento in cui il peso considerevole delle risorse aziendali viene mobilitato per capitalizzare la moralità pubblica. Quando la nostra stessa moralità viene imbrigliata e sfruttata come risorsa aziendale, dietro c’è sempre all’opera l’interesse privato delle imprese1”.
Il capitalismo dell’indecenza ha dunque preso in carico una serie di iniziative favorevoli ai diritti individuali e all’ambiente per presentarsi ai popoli e alle classi come il liberatore degli infelici, sensibile all’ambente che ha devastato. In questa fantasmagorica manipolazione delle parole e dei fatti ha raggiunto il suo obiettivo finale: eliminare la politica e presentarsi come l’unica sinistra credibile. Il gioco è facile: inclusione, femminicidio, parità di genere ecc. sono temi che raccolgono un facile consenso e cle il capitalismo woke appoggia e incentiva. Si procede per slogan, non si effettuano analisi strutturali, pertanto lo spot è accolto mollemente dai popoli, ormai plebe. La politica tace, anzi a sinistra si applaude alla sua effettiva sostituzione e si inneggia al capitale. I popoli devono credere alla versione del mondo secondo il credo delle oligarchie, devono rivolgersi ai capitalisti per imparare a decodificare la storia e il mondo sociale. L’economia ha fagogitato la politica, la quale è a suo servizio. La sovranità dei popoli è superata dal polulismo aziendale:
“Al contrario, il vero pericolo del capitalismo woke non è che indebolisca il sistema capitalistico, quanto piuttosto che consolidi ulteriormente la concentrazione del potere politico nelle mani di un’élite aziendale. Il perdurare di questa tendenza costituisce una minaccia alla democrazia. Ed è inoltre una minaccia per la politica progressista che ha ancora il coraggio di sperare nell’uguaglianza, nella libertà e nella solidarietà sociale2”.
Il lupo e l’agnello
Andrew Forrest è un tipico esempio di capitalismo woke. Nel 2020 l’Australia è stata devastata dagli incendi, il magnate ha versato 70 milioni di dollari in beneficenza per il disastro ambientale, solo che ben 50 milioni sono rientrati nella sua fondazione la Minderoo Foundation. La beneficenza è un affare, si finanziano fondazioni, i cui risultati finali saranno in linea con le aspettative del benefattore, che in tal modo produrrà merci e tecnologie presentandole sul mercato come innovative e “green”. Le emergenze sono prodotte in laboratorio, sono un tipo speciale di merce da vendere alla plebe.
La fondazione del “benefattore”, dunque, non potrà che confermare la versione ufficiale sui cambiamenti climatici, di conseguenza orienterà e condizionerà l’opinione pubblica con la sua aureola etica e nel contempo supporterà la vendita della merce che risolve l’emergenza. Il ciclo produttivo si chiude:
“Tutto bene, finché non si guarda in bocca a caval donato. Dei 70 milioni di dollari promessi, 10 sono stati destinati direttamente alle vittime degli incendi e altrettanti sono stati dati per finanziare un “esercito di aiutanti”, i quali avrebbero contribuito alla ripresa. I restanti 50 milioni di dollari sono stati offerti alla ricerca sulla “riduzione degli incendi”, alla cui guida c’è però la Minderoo Foundation che è di sua proprietà, sollevando così il dubbio sui risultati, che dovranno essere in linea con gli interessi del suo titolare. Ecco quindi che, tutto a un tratto, la sua donazione è sembrata piuttosto un investimento3”.
Vi sono momenti storici nodali, in cui la verità diventa palese e inaggirabile. Sono storici momenti, in cui i popoli possono passare dalla condizione di plebe a quella di popolo consapevole di essere “classe sociale allargata” che può emanciparsi dal giogo alienante delle menzogne. Durante la pandemia di Covid 19 le multinazionali non solo hanno acquisito aziende e imprese più deboli fallite per la chiusura generalizzata, ma hanno richiesto allo Stato i sovvenzionamenti per i “danni subiti”, mentre i lavoratori erano forzatamente disoccupati, e molti non sarebbero tornati più al lavoro. Ecco il volto autentico del capitalismo, dietro la patina del progressismo vi sono solo gli interessi delle oligarchie:
“Il fatto che essi abbiano usato la crisi per rimpinguare le proprie casse è una presa in giro crudele ed egoista. Nel momento della difficoltà, ovunque nel mondo le multinazionali si sono messe in fila a piangere miseria nella speranza di ottenere aiuti governativi contro il coronavirus finanziati dai contribuenti. Per decenni, il dogma neoliberista ha privilegiato le multinazionali, insistendo sulla necessità di avere governi poco interventisti rispetto alla regolamentazione delle imprese, al welfare e all’istruzione. La perversione dell’interesse personale ha quindi raggiunto il colmo quando proprio coloro che hanno ferocemente pasteggiato alla tavola neoliberista sono stati i primi a mettersi in fila per ottenere i sussidi (alle aziende). La messa in cassa integrazione e l’aumento della disoccupazione di massa causati dalla crisi del COVID-19 hanno mostrato le priorità delle imprese. Così come il rischio che aziende ricche di liquidità, quali Apple, Johnson & Johnson e Unilever, rafforzassero il loro potere monopolistico acquisendo le concorrenti più piccole in lotta per la sopravvivenza4”.
Il monopolio sempre più accentuato nega nei fatti i principi liberisti e liberali che le imprese proclamano. Siamo dinanzi ad un nuovo feudalesimo, in cui pochi soggetti sono i padroni della politica e dell’economia. Si tratta di un travestimento che bisogna smascherare. Il lupo si è travestito da agnello per disorientare e occultare le ragioni reali del “progressismo capitalistico”.
Egemonia culturale
Per poter dominare incontrastato in una realtà pacificata e adialettica il capitalismo woke deve controllare la struttura e la sovrastruttura, inaugura in tal modo un totalitarismo inedito e lasco. Orienta l’opinione pubblica su talune cause sociali, abbraccia l’uguaglianza dei diritti, si veste di arcobaleno, presentandosi come l’unica alternativa possibile. La popolarità nell’aver sposato “cause gettonate” consente ai miliardari di conservare l’iniqua distribuzione delle risorse, la precarietà sociale e il taglio allo stato sociale con il consenso di molti, specie delle nuove generazioni che non conoscono nulla al di là del capitalismo. Si tratta di una operazione egemonica ben pianificata, politica ed economia coincidono pericolosamente:
“Per Dreher, il capitalismo woke è una forma di «imperialismo culturale» o «totalitarismo morbido», in cui l’adozione da parte delle imprese di posizioni progressiste esercita una notevole pressione politica su altri soggetti – ad esempio i dipendenti –, affinché sposino quelle stesse posizioni, anche se non ci credono. L’esempio da lui citato è quello dell’IKEA, la multinazionale svedese che ha licenziato un dipendente per aver disapprovato il sostegno dato dall’azienda al movimento del gay pride, perché in contrasto con le sue convinzioni religiose5”.
Dinanzi al capitalismo antropofago che ha divorato la politica e la cultura, l’unica alternativa per restare umani e riportare la storia ai popoli è riaffermare il primato della politica-cultura sull’economico:
“Il vero cambiamento viene dall’azione democratica, non dalle aziende che vanno avanti da sole. È tempo di abbandonare l’idea che le imprese, in quanto attori principalmente economici, possano in qualche modo aprire la strada politica per un mondo più giusto, equo e sostenibile. La politica democratica si fonda sulla convinzione che le persone abbiano il diritto di governarsi da sole. Questa politica deve essere riaffermata come primaria, mentre l’economia deve retrocedere in secondo piano. Con il capitalismo woke, invece, abbiamo visto la tendenza opposta toccare un culmine pericoloso, perché le organizzazioni capitalistiche hanno sconfinato sempre più nella vita morale e politica dei cittadini6”.
Siamo in un momento storico, in cui il pericolo è diventato minaccioso, ma quando il pericolo rischia di annientare una intera civiltà il risveglio della coscienza di “classe allargata a strati ampi della popolazione” è determinante.
Per neutralizzare tale deriva bisogna volgere lo sguardo agli effetti e ai dati oggettivi del capitalismo dal “volto umano” e fugare, così, le ombre in cui siamo.
Ciascuno con il suo impegno può contribuire a riportare la verità, dove vige la manipolazione pianificata. Tutti siamo chiamati a contribuire alla formazione, dal basso, di una nuova coscienza comunitaria e comunista con la quale riaprire “il sentiero interrotto della politica”.
Note
- 1 Carl Rhodes Capitalismo woke, come la moralità aziendale minaccia la democrazia, Fazi editore, Roma 2023, Capitolo I Il problema del capitalismo, pp. 22 23
- 2Ibidem pag. 25
- 3 Ibidem Capitolo Populisti aziendali pag. 32
- 4 Ibidem pp. 40 41
- 5 Ibidem, Capitolo VI Un lupo in abiti woke, pag. 94
- 6 Ibidem Capitolo XIII Diventare woke nei confronti del capitalismo woke pag. 197
Michele Blanco LINK
Globalizzazione delle disuguaglianze e delle ingiustizie / di Michele Blanco*
 Negli anni Ottanta del secolo scorso si descriveva il futuro prossimo della globalizzazione come di una età di crescita del benessere diffuso per tutta l’umanità, in tutti i paesi del mondo, ma «Oggi, invece, la crescente disuguaglianza non ha prodotto alcun conflitto di classe che minacci il sistema capitalistico, e ciò sebbene nelle economie avanzate questa si sia accompagnata con la deindustrializzazione e la schiavitù del debito.
Negli anni Ottanta del secolo scorso si descriveva il futuro prossimo della globalizzazione come di una età di crescita del benessere diffuso per tutta l’umanità, in tutti i paesi del mondo, ma «Oggi, invece, la crescente disuguaglianza non ha prodotto alcun conflitto di classe che minacci il sistema capitalistico, e ciò sebbene nelle economie avanzate questa si sia accompagnata con la deindustrializzazione e la schiavitù del debito.
È in questo contesto politico che una nuova generazione di miliardari ha abbracciato la filantropia. … non si può più fare affidamento sullo Stato per affrontare le ingiustizie sociali e le povertà. Al contrario la società si rivolge alle briciole filantropiche che cadono dalla tavola del padrone; bruscolini che cadono solamente lì dove i super ricchi decidono di farli cadere … ma guardando bene, esso appare un disegno complesso, volto a garantire che il sistema che ha generato le diseguaglianze, per le quali la filantropia è un unguento, permanga del tutto invariato», in Carl Rhodes, Capitalismo woke. Come la moralità aziendale minaccia la democrazia, Roma, Fazi, 2023, pp. 251 e 254.
La globalizzazione oggi è certamente e identificata come causa di ingiustizie e tensioni sociali. Nel mondo contemporaneo possiamo parlare di tanti tipi di disuguaglianze, ma certamente, da un punto di vista economico, si può parlare della disuguaglianza tra tenori di vita, distinguendo fondamentalmente tra due tipi di tali disuguaglianze, quella mondiale (tra le nazioni) e quella all’interno delle singole nazioni. Quando si dice ad esempio che il 10% più povero ha un tenore di vita pari a un decimo del 10% dei più ricchi ovviamente non ha lo stesso significato in India e in Svizzera. Conviene allora aggiungere una regola generale quando si valuta la disuguaglianza: stabilire una soglia assoluta di povertà e il valore più utilizzato oggi è quello di circa un euro al giorno pro capite.
Considerando la disuguaglianza tra stati, dopo un secolo circa di continuo aumento, la disuguaglianza tra stati da più di vent’anni a questa parte ha iniziato a diminuire, se nel 1989 il tenore di vita in Francia e in Germania era di venti volte superiore a quello della Cina o dell’India, oggi questo divario si è dimezzato. D’altra parte la disuguaglianza all’interno di molti paesi è invece andata aumentando. Una spiegazione della diminuzione della disuguaglianza tra stati negli ultimi 20 anni è dovuta alla innovazione tecnologica, al miglioramento dell’istruzione, alla formazione della manodopera, alle conoscenze tecniche e scientifiche. Ovviamente non tutti i paesi in via di sviluppo stanno conoscendo questo processo di crescita.
Per quanto riguarda l’altro tipo di disuguaglianza, quella all’interno dei singoli stati, questa è leggermente aumentata nel corso del 19° secolo, per poi ridursi notevolmente tra la prima guerra mondiale e il secondo dopoguerra, fino agli anni Settanta del secolo scorso. La realizzazione di grandi sistemi di redistribuzione e anche l’egualitarismo imposto dalle rivoluzioni russa e cinese sui propri territori ha portato a ridurre tale disuguaglianza nella maggior parte dei paesi sviluppati. Dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso la disuguaglianza interna agli stati occidentali è andata aumentando. Lo sviluppo dei paesi emergenti e, in misura minore, di quelli in via di sviluppo contribuisce a ridurre la disparità tra i tenori di vita degli abitanti dell’intero pianeta, ma l’aumento delle disuguaglianze interne tende, al contrario, ad aumentarla.
Dato che il problema delle disuguaglianze è abbastanza uniforme, è difficile non collegarlo a cause comuni, e in particolare alla globalizzazione. Essa ha favorito la formazione di un mercato finanziario globale in cui le tecnologie della comunicazione consentono il trasferimento in pochi secondi di enormi capitali da un continente all’altro. L’informazione non ha limiti, quindi la crisi della borsa di un paese si riflette, nel giro di pochi minuti sulle borse degli altri paesi.
Il termine “villaggio globale”, che ormai è di uso comune, esprime bene la velocità e la diffusione della comunicazione nel mondo, per cui le notizie e le conoscenze non sono più ristrette a un numero limitato di individui ma diffuse e condivise in tutto il globo. Il potere della conoscenza delle tecnologie: le innovazioni tecnologiche non sono più necessariamente nei beni e nei servizi scambiati, ma sono incorporate nelle menti degli individui. In altre parole, per trarre vantaggio, in termini tecnico-scientifici, dalla conoscenza, occorre aver superato una determinata soglia di sapere, in modo da poter dialogare con tale conoscenza. Iperconcorrenza: la legge della competitività portata alle estreme conseguenze. Perdita costante di rilevanza della società statale, dello stato o del sistema nazionale. Formazione di una cultura globale, fortemente ispirata al consumismo e diretta dalla comunicazione del marketing.
La globalizzazione si rivela come un fenomeno dalle caratteristiche assolutamente ambivalenti: c’è chi la mitizza e ne mette in luce gli aspetti positivi, come le differenze nella ricchezza delle nazioni si siano alquanto livellate, portando il tenore di vita medio dei cittadini di paesi emergenti come il Brasile, la Cina e l’India ad avvicinarsi a quello di nordamericani ed europei, ma riguarda solo le classi medie di tali paesi, e chi la demonizza, pensandola causa di tanti mali.
Quello che sappiamo è che all’interno dei paesi occidentali ha invece certamente contribuito all’aumento delle disuguaglianze, infatti attraverso la globalizzazione viene diminuita la remunerazione relativa del lavoro scarsamente qualificato, che subisce la concorrenza diretta della manodopera a buon mercato delle economie emergenti, e vengono aumentati eccessivamente i profitti del capitale. Questo ci sembra evidente e innegabile. In molti inoltre ritengono che la globalizzazione sia un fenomeno che impoverisce ancora di più i già poveri e arricchisce ancora di più i ricchi. Ma il fenomeno fondamentale che ha caratterizzato il periodo della globalizzazione neoliberista è il taglio delle tasse pagate da chi ha redditi più elevati. Infatti dal punto di vista della distribuzione, le riforme più importanti sono state le modifiche alla tassazione, in particolare i tagli alle imposte sul reddito.
La giustificazione fornita era che le aliquote marginali sui redditi più alti erano praticamente confiscatorie scoraggiavano l’imprenditorialità e gli investimenti, incentivando l’evasione e l’ottimizzazione. Aliquote fiscali più basse erano intese a ripristinare questi incentivi e per ridurre l’evasione fiscale, mantenendo al contempo le entrate fiscali ai livelli esistenti. L’aliquota marginale più elevata è scesa dal 70% al 40% negli Stati Uniti durante l’amministrazione Reagan. Nel Regno Unito, è precipitato dall’83% al 60% nel primo anno del governo Thatcher mentre, contemporaneamente l’imposta sul valore aggiunto è salita dal 6% al 15%, come è facile vedere una riforma profondamente regressiva.
Più tardi, molti altri paesi adotterebbero misure simili, anche se non del tutto di vasta portata: la Germania nel 1986-1990, poi dì nuovo nel 2003, Francia nel 1986 e nel 2002. Un esempio drammatico di questo è stata la “riforma fiscale del secolo” della Svezia nel 1991. In questo paese tradizionalmente egualitario con un sistema fiscale fortemente redistributivo, l’aliquota marginale più alta è scesa dal 70% al 45%, mentre è aumentata l’aliquota fiscale indiretta per compensare almeno parte delle entrate perse. Come nel Regno Unito, la disuguaglianza aumentata in modo sostanziale. Le variazioni delle aliquote marginali più elevate sono solo una piccola parte delle riforme fatte in nome della liberalizzazione economica. Una caratteristica importante di queste riforme pro globalizzazione, anche essa legata alla crescente mobilità del capitale nel contesto della globalizzazione è stata l’introduzione della distinzione tra tassazione del reddito da capitale e risparmio e la tassazione del reddito da lavoro. Nel corso del tempo si è evoluto un sistema duale in cui i reddito da risparmio erano tassati a tassi forfettari non progressivi che erano destinati a essere più o meno simili tra i paesi e comunque inferiori alle più elevate aliquote marginali sul reddito da lavoro. Poiché la quota dei redditi da capitale tende ad aumentare del reddito, le aliquote d’imposta medie per le fasce di reddito molto alte sono effettivamente diminuite.
Questo era vero in Francia, negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi sviluppati. Allo stesso modo, le aliquote fiscali sugli utili societari sono state ridotte anche nella maggior parte delle economie sviluppate, con l’ovvio risultato che la tassazione diretta è diventata sempre più meno progressiva. Negli Stati Uniti, ad esempio, un’analisi che teneva conto delle imposte federali su reddito, profitti, eredità e costi del personale ha mostrato che l’aliquota effettiva dell’1% più ricco diminuiva di circa 15 punti percentuali tra il 1970 e il 2004, spesso diminuendo sotto quello pagato dalla borghesia.
All’altro estremo della scala, c’è stata una generale riduzione della redistribuzione alla fascia di popolazione a più basso reddito, con tagli siano avvenuti al welfare in molti paesi. Il welfare state nel Regno Unito ha subito gravi tagli sotto il governo Thatcher e la crisi economica in Svezia nei primi anni ’90 ha portato il paese a riformare il suo sistema di protezione sociale. In entrambi i casi, le riforme hanno portato a un aumento della disuguaglianza rispetto a un sistema di tassazione meno progressista. In altri paesi, la spesa sociale è stata allo stesso modo ridotta. Tutto questo è continuato nel mondo occidentale in modo costante fino ai nostri giorni.
Secondo alcuni economisti, si dice efficiente una situazione in cui non è possibile aumentare il benessere di un soggetto senza diminuire quello di un altro. Ma oggi di sicuro, sappiamo che troppa disuguaglianza ostacola il funzionamento dell’economia e in modo particolare la crescita economica, tanto decantata dagli economisti come la panacea di tutti i mali. Come quando in una nazione ci sono alunni dotati che però non hanno accesso all’istruzione superiore perché le loro famiglie non possono permetterselo, e viceversa vanno all’università ragazzi anche non particolarmente dotati, nati in ambienti privilegiati: questo ci sembra un chiaro esempio di economia non efficiente. Così, ad esempio, uno stato in cui c’è una violenza endemica, come in tantissime nazioni africane per esempio, non potrà avere un’economia efficiente perché la popolazione e lo stato saranno costretti a destinare gran parte del loro bilancio alla sicurezza.
François Bourguignon in La globalizzazione della disuguaglianza, Torino, Cortina, 2013, afferma che in questo contesto un dato positivo è la comparsa di una coscienza mondiale del legame che collega globalizzazione e disuguaglianze. La necessità attuale sarebbe sufficiente che i paesi sviluppati ed emergenti fossero in grado di controllare l’incremento delle disuguaglianze interne alle proprie economie per fermare la globalizzazione della disuguaglianza conservando al contempo i lati positivi della globalizzazione. La lotta alle disuguaglianze deve diventare impresa comune. Evitare la globalizzazione della disuguaglianza passa attraverso una globalizzazione della redistribuzione.
Infatti ci troviamo in un mondo globalizzato, in un villaggio globale, veniamo a conoscenza continuamente di ciò che avviene nella altre parti del pianeta e quindi non possiamo ignorarlo, dobbiamo sentircene responsabili. Tuttavia quello che noi veniamo a conoscere è selezionato non secondo nostre scelte, ma secondo ciò che taluni decidono di farci conoscere, questo accade sempre di più. Inoltre la manipolazione dell’informazione riesce a confezionare le notizie riuscendo a far passare un crimine efferato come un bombardamento sulle popolazioni civili in uno Stato sovrano e indipendente come una guerra umanitaria. Se a bombardare sono gli occidentali e i loro alleati diventa “un intervento umanitario” se sono altri è un “efferato crimine contro l’umanità”. E magari quando non fa più notizia, queste informazioni si spengono, anche se i problemi e le tragedie restano. Ciò significa che siamo, sì, globali, ma non siamo un “villaggio”: in un villaggio ci si guarda negli occhi, ci si conosce, si condividono le gioie e le pene di tutti. In definitiva, la globalizzazione deve essere per l’uomo. Si spera che lo sia per l’umanità intera ma deve iniziare dal considerare tutte le persone con gli stessi diritti e opportunità, senza distinzione alcuna, ma gli avvenimenti del mondo contemporaneo dimostrano chiaramente che esistono persone che hanno un valore e altre che ne hanno, purtroppo di meno. Basta guardare il valore dato alla vita e alle sofferenze di un bambino palestinese, o del Sud Sudan, confrontata con il valore dato alla vita e alle sofferenze dei bambini europei, che devono assolutamente essere la stessa cosa. Tutto queste ignobili differenze non sono tollerabili ne ammissibile in nessun caso, in nessuna parte del mondo.