MR 2023/12 I media corporativi, le élite politiche e la guerra perpetua / D.M.Smith
Argomenti:
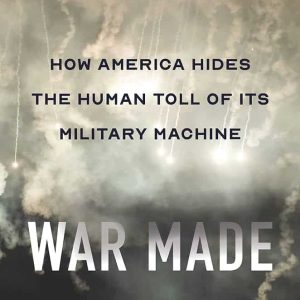
David Michael Smith è un ex professore di governo e presidente del sindacato presso il College of the Mainland di Texas City, in Texas. È autore di Endless Holocausts: Mass Death in the History of the United States Empire (New York: Monthly Review Press, 2023).
Norman Solomon, La guerra resa invisibile: come l’America nasconde il tributo umano della sua macchina militare (New York: The New Press, 2023), 272 pagine, $ 27,99, copertina rigida.
Da tempo riconosciuto come uno dei giornalisti e critici dei media più incisivi di questo paese, Norman Solomon ha scritto un nuovo libro che merita di essere letto ampiamente. In meno di trecento pagine, raccoglie una notevole quantità di informazioni per documentare i contorni della cosiddetta guerra al terrorismo condotta dagli Stati Uniti dopo l’11 settembre, i terribili costi umani sostenuti all’estero e in patria, e i modi in cui i media corporativi e le élite politiche si sforzano di rendere questa guerra perpetua e le sue conseguenze catastrofiche quasi del tutto invisibili al pubblico. Il libro è pieno di importanti approfondimenti su come l’establishment dei media e i funzionari governativi di entrambi i principali partiti politici promuovano gli interessi del complesso militare-industriale. In War Made Invisible, i lettori troveranno anche un eloquente appello morale a porre fine a questo stato di cose. Tutto considerato, questo volume è un prezioso contributo alla letteratura sul ruolo dei media corporativi e delle élite politiche nel sostenere la guerra al terrorismo.
Ventisei giorni dopo l’attacco dell’11 settembre agli Stati Uniti, il presidente George W. Bush ordinò il bombardamento dei campi di addestramento di al Qaeda e degli obiettivi militari talebani in Afghanistan. Anche se il regime talebano è caduto nel giro di due mesi, Solomon spiega che la guerra al terrorismo era “solo all’inizio” (2). Egli osserva che questa rubrica “è diventata – per la Casa Bianca, il Pentagono e il Congresso – una licenza politica per uccidere e spostare le persone su larga scala” (3). Migliaia di militari statunitensi, truppe alleate e appaltatori militari combatterono contro i talebani per i successivi due decenni e inflissero enormi perdite, ma alla fine furono costretti a ritirarsi. L’invasione dell’Iraq da parte dell’amministrazione Bush nel marzo 2003 ha portato a una perdita di vite umane ancora più disastrosa, ha destabilizzato l’intera regione e “ha favorito la formazione di gruppi terroristici come l’ISIS” (30). Importanti interventi militari si sono verificati anche in Pakistan, Siria, Libia, Yemen, Somalia e Filippine. Complessivamente, gli Stati Uniti hanno bombardato un totale di ventidue paesi in quattro continenti dall’ottobre 2001.
Solomon cita la scoperta del Costs of War Project della Brown University secondo cui “almeno 929.000 persone sono morte a causa della violenza diretta della guerra” e “molte volte di più sono morte indirettamente” (160). Le guerre di Washington hanno causato tra i 38 e i 60 milioni di persone in otto paesi (138, 160). Gli effetti a lungo termine includono “la decimazione di intere società e nazioni”, lo “schiacciamento delle infrastrutture”, la “distruzione ecologica” e “il terrore imposto alla vita quotidiana per anni e anni” (96). La guerra perpetua ha anche profondi costi interni. Più di quindicimila militari e appaltatori statunitensi sono morti e a centinaia di migliaia è stata diagnosticata una lesione cerebrale traumatica. Il suicidio, la violenza domestica e l’aggressione sessuale affliggono il personale in servizio attivo e i veterani. Inoltre, il bilancio militare “assorbe fondi che potrebbero essere dedicati all’assistenza sanitaria, all’istruzione, all’alloggio, alla creazione di posti di lavoro e molto altro” (156). Gli appaltatori militari raccolgono “profitti giganteschi” dalla guerra perpetua “mentre le condizioni economiche sono peggiorate o sono rimaste precarie per la maggior parte degli americani” (157).
Questo libro sottolinea l’importanza sia dell’omissione che della ripetizione nella propaganda di guerra degli Stati Uniti. Per Solomon, la lacuna più importante dopo l’11 settembre sono i milioni di morti, in gran parte di persone di colore. Inoltre, queste morti sono “avvenute quasi completamente fuori dalla vista e dalla mente” (13). L’orribile tributo di vite umane in Afghanistan, Iraq e altri paesi attaccati dagli Stati Uniti è stato “di poca o nessuna conseguenza mediatica” (8). Invece di rendere la guerra più umana, la tecnologia avanzata del Pentagono, la potenza aerea e i droni remoti hanno ucciso più civili che combattenti, anzi, “molti più civili di quanti ne abbiano fatti al Qaeda e altri gruppi terroristici” (30). Eppure i politici e i dirigenti dei media in gran parte ignorano – e disumanizzano – coloro che muoiono in terre lontane. Di conseguenza, le persone negli Stati Uniti sono “condizionate ad accettare le guerre in corso senza mai sapere veramente cosa stanno facendo a persone che non vedremo mai” (15). Solomon contrappone l’invisibilità virtuale delle morti nella guerra al terrorismo con i “riflettori da parete a parete degli orrori della guerra in Ucraina” dei media (134). Come ha osservato Hassan El-Tayyab del Comitato degli Amici per la Legislazione Nazionale, questo contrasto rivela che “le vite dei bianchi contano di più per loro delle vite dei neri e dei marroni” (134).
Inoltre, l’establishment dei media ha costantemente ribadito la logica di Washington per la guerra al terrore. Dopo l’11 settembre, molti media sono stati “riempiti di appelli alla punizione” e hanno energicamente appoggiato l’intervento militare in Afghanistan (7). Molti di loro hanno anche ripetuto a pappagallo le false affermazioni dell’amministrazione Bush sulle armi di distruzione di massa irachene e sui legami con al Qaeda. Dopo l’inizio dell’invasione dell’Iraq, “la copertura affermativa delle notizie era una procedura operativa standard” e i resoconti dei giornalisti incorporati con le truppe statunitensi portarono il pubblico “a identificarsi con gli attentatori invece che con le persone che venivano bombardate” (26, 27). Solomon sottolinea che il militarismo sistemico degli Stati Uniti storicamente “riceve poca attenzione pubblica”, e mentre il dibattito su “come, dove e quando” andare in guerra può essere trovato nei media, “la prerogativa dell’intervento militare è a malapena messa in discussione” (17-18). Invece, i funzionari governativi e i media invocano continuamente la retorica dell'”eccezionalismo americano”, che Solomon denuncia come “raffinatezza” che nasconde gli orrori del militarismo degli Stati Uniti (196). Citando Daniel Ellsberg, egli attacca i media per aver promosso la finzione che “siamo superiori nella nostra moralità e nella nostra percezione del mondo”, mentre nasconde il fatto che siamo “cittadini di un impero”, che afferma “il diritto di determinare chi governa gli altri paesi” (194-95).
La maggior parte dei giornalisti statunitensi non è stata disposta a “rompere i ranghi con l’essenza delle narrazioni ufficiali di guerra di Washington” (34-35). Con rare eccezioni, i conduttori, i commentatori e i giornalisti in studio accettano “come un dato di fatto le buone intenzioni dei politici statunitensi” e diffondono le posizioni del governo (77). I media glorificano regolarmente il personale militare degli Stati Uniti, dipingendolo come difensore della libertà invece che come dispensatore di morte in tutto il mondo. Accademici, giornalisti e attivisti che si oppongono alle guerre di Washington sono raramente invitati a condividere le loro opinioni. Sebbene siano apparsi “esempi di giornalismo di alta qualità e controcorrente” sulla guerra al terrorismo, si tratta di eccezioni (102). Quando le invasioni dell’Afghanistan e dell’Iraq non sono riuscite a raggiungere gli obiettivi strategici degli Stati Uniti e il sostegno pubblico è diminuito, alcuni media e politici hanno iniziato a definire le guerre “errori” (186). Ma la “comoda amnesia” sugli inganni precedenti, le “affermazioni fatue sul passato” e il “racconto tardivo di verità parziali” dimostrano la “menzogna strutturale” del complesso militare-industriale (186-1887).
I leader dei media aziendali si assicurano che i dipendenti comprendano il loro punto di vista sul ruolo degli Stati Uniti negli affari internazionali e agiscano di conseguenza. Dopo l’inizio dell’attacco all’Afghanistan, il presidente della CNN Walter Isaacson ordinò ai giornalisti di non riferire sui morti e i feriti civili senza ricordare le sofferenze delle vittime dell’11 settembre. Oltre alle pressioni del “nazionalismo, del mercantilismo e del conformismo professionale”, le “preoccupazioni dei giornalisti per la sicurezza del lavoro” e i “desideri di avanzamento di carriera” favoriscono l’accondiscendenza e l'”autocensura” (20). Le esperienze di Phil Donahue e Ashleigh Banfield dimostrano cosa può succedere ai giornalisti che escono dalle righe. Donahue, il conduttore del programma di prima serata più apprezzato di MSNBC e una delle poche voci di spicco dei media che si oppongono all’invasione dell’Iraq, è stato licenziato tre settimane prima dell’inizio dei bombardamenti. Un memorandum interno trapelato spiegava che il suo programma rappresentava “un volto pubblico difficile per la NBC in tempo di guerra” (184). In un discorso alla Kansas State University un mese dopo l’invasione dell’Iraq, Banfield, un acclamato corrispondente e astro nascente di MSNBC, ha criticato la “gloriosa, meravigliosa immagine” della guerra da parte dei media perché “ci sono orrori che sono stati completamente tralasciati” (73). I dirigenti della rete rimproverarono pubblicamente Banfield e la sua carriera alla MSNBC giunse presto al termine.
Sebbene War Made Invisible sia un prezioso contributo alla letteratura sulla guerra al terrore, parte di ciò che l’autore dice – e non dice – invita a un esame critico. Il libro probabilmente sopravvaluta il successo degli sforzi dei media corporativi e delle élite politiche per “nascondere il tributo umano” del militarismo statunitense. Come hanno affermato Edward S. Herman e Noam Chomsky in Manufacturing Consent, la “propaganda proveniente dai media” non è sempre efficace.1 Solomon non menziona le decine di migliaia di persone negli Stati Uniti che hanno marciato contro la guerra in Afghanistan. Né dice molto sulle centinaia di migliaia di persone che hanno protestato contro l’invasione dell’Iraq, e la sua affermazione che “hanno attirato poca copertura mediatica” è sconcertante (191). Molti media hanno parlato dell’opposizione interna ed estera, anche se hanno ripetuto le menzogne dell’amministrazione Bush sull’invasione.2 Nel giro di due anni, l’opinione pubblica statunitense aveva cominciato a rivoltarsi contro la guerra in Iraq.3 Solomon riconosce che la credibilità del governo è “gravemente corrosa” dopo vent’anni di guerra al terrore, ma i media corporativi e la propaganda governativa potrebbero avere una portata ancora più limitata di quanto suggerisca (186). Questo volume sarebbe stato più forte se avesse esplorato le ramificazioni del declino della fiducia del pubblico nei media tradizionali e nelle istituzioni governative e il ruolo crescente dei social media come fonti di notizie.
Sfortunatamente, Solomon equivoca sulla questione degli omicidi deliberati commessi dalle forze militari statunitensi. Egli sostiene che “a differenza di gruppi terroristici come al Qaeda e i loro leader jihadisti, il governo degli Stati Uniti e i suoi pianificatori di guerra non uccidono deliberatamente i civili”, anche se tali morti sono “prevedibili” e “virtualmente inevitabili” come risultato di “priorità politiche” (53-54). Egli ammette che «per coloro che sono stati uccisi e per i loro cari, il contrasto può essere una distinzione senza differenza» (53). Tuttavia, in un’altra parte del libro, Solomon condanna “l’uccisione di undici civili iracheni” da parte del fuoco di un elicottero da combattimento a Baghdad nel 2007 (122). Fa notare che l’editore di WikiLeaks, Julian Assange, ha pubblicato “enormi quantità di documenti” sui “massacri di civili da parte dell’esercito americano” ricevuti dall’ex analista dell’intelligence statunitense Chelsea Manning (123). Solomon loda anche Manning per “non aver solo rivelato gli ‘errori’, ma anche per aver portato alla luce modelli di crimini di guerra” (124). E’ incontrovertibile che il personale militare degli Stati Uniti abbia intenzionalmente ucciso molti non combattenti nella guerra al terrore.4 Poiché le morti di civili sono spesso “prevedibili” e “virtualmente inevitabili” nelle operazioni militari, i comandanti che ordinano tali azioni stanno anche implicitamente autorizzando l’uccisione di non combattenti.
Solomon esagera il significato storico della guerra al terrorismo quando afferma che essa ha “normalizzato la guerra come uno stile di vita americano in corso” (179). La guerra perpetua e la sua routinizzazione non sono certo sviluppi del ventunesimo secolo. Gli Stati Uniti sono stati in guerra – di un tipo o dell’altro – sin dalla loro fondazione.5 La storia degli Stati Uniti include guerre genocide contro i popoli indigeni; guerre espansionistiche contro la Gran Bretagna, il Messico, la Spagna e le Filippine; la guerra civile; due guerre mondiali; l’invasione della Russia sovietica; le guerre anticomuniste in Corea, Vietnam, Laos e Cambogia; la guerra del Golfo; l’attuale guerra al terrorismo; e molto altro ancora. Come ho sostenuto altrove, i governanti degli Stati Uniti sono responsabili o condividono la responsabilità di centinaia di milioni di morti correlate.6 L’uccisione intenzionale di civili in altri paesi è stata a lungo una caratteristica particolarmente oltraggiosa delle operazioni militari statunitensi. Alcuni dei più famigerati massacri statunitensi si verificarono a Kuala Batu, Sumatra, nel 1832; Veracruz e Città del Messico, Messico, nel 1847; Samar, Filippine, nel 1901; Les Cayes, Haiti, nel 1929; No Gun Ri, Corea, nel 1950; My Lai, Vietnam, nel 1968; e Belgrado, Jugoslavia, nel 1989.7 Circa un milione di civili morirono nei bombardamenti statunitensi e britannici sulle città giapponesi e tedesche durante la seconda guerra mondiale.8 Delle oltre duecentomila persone che morirono a Hiroshima e Nagasaki, la stragrande maggioranza non erano combattenti.9
Infine, War Made Invisible non si confronta direttamente con il sistema economico capitalista in cui sono radicati il complesso militare-industriale e lo “stato di guerra” (188). Salomone ammette che questa società possa essere una “oligarchia”, descrive le conseguenze interne della guerra perpetua come il prodotto della “guerra di classe” e cita alcune fonti che si riferiscono all'”impero” e all'”imperialismo” (143, 151, 156-57, 194). Riconosce anche la centralità degli interessi petroliferi nell’invasione dell’Iraq. Tuttavia, non riconosce gli imperativi di espansione e accumulazione insiti nel capitalismo e nella sua inesorabile spinta strutturale a sfruttare le risorse, i mercati e il lavoro delle persone in altri paesi. Solomon critica “l’eccezionalismo americano” per aver nascosto “il nudo interesse personale, l’esaltazione, le prese di profitto dalla vendita di armi, la leva internazionale per il guadagno economico e il posizionamento geopolitico” (196). Tuttavia, c’è ancora molto da dire sulla classe dominante degli Stati Uniti, sul capitalismo monopolistico-finanziario contemporaneo e sull’imperialismo. Solomon invoca l’opposizione di Martin Luther King Jr. al militarismo, al razzismo e alla povertà, ma rifiuta di menzionare la sua critica al capitalismo. Eppure King ha insistito sul fatto che questi “mali” sono “profondamente radicati nell’intera struttura della nostra società”.10 È ironico che Solomon concluda il libro citando l’osservazione di James Baldwin che “nulla può essere cambiato finché non viene affrontato” (197). Porre fine al militarismo e alla guerra perpetua degli Stati Uniti ci richiederà di affrontare la verità sul capitalismo e la necessità di ciò che King chiamava “la ricostruzione radicale della società stessa”.11
Note
- ↩ Edward S. Herman e Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (New York: Pantheon, 2002), xii.
- ↩ Si veda, ad esempio, “Cities Jammed in Worldwide Protest of War in Iraq”, New York Times, 16 febbraio 2003; Michael Janofsky, “Raduni contro la guerra a Washington e in altre città”, New York Times, 25 settembre 2005; “Stelle contro la guerra in Iraq”, CBS News, 29 gennaio 2007; e Kristen M. Daum, “Le proteste segnano il 5° anniversario della guerra in Iraq”, Los Angeles Times, 20 marzo 2008.
- ↩ “Atteggiamenti pubblici verso la guerra in Iraq: 2003-2008”, Pew Research Center, 19 marzo 2008.
- ↩ Alcuni esempi sono discussi in Douglas Jehl, “Army Details Scale of Abuse in Afghan Jail”, New York Times, 12 marzo 2005; Declan Walsh, “Registri di guerra in Afghanistan: come i marines statunitensi hanno sterilizzato il record del bagno di sangue”, Guardian, 26 luglio 2010; Barbara Starr, “Esercito: 12 soldati uccisi afgani, cadaveri mutilati”, CNN, 10 settembre 2010; Emma Graham-Harrison, “U.S. Soldier Kills up to 16 civilian in Shooting Spree”, Guardian, 11 marzo 2012; Edmund Blair, “La rabbia monta dopo che le truppe statunitensi uccidono 13 manifestanti iracheni”, Reuters, 29 aprile 2003, archiviato in Common Dreams News Center, commondreams.org; Charlie Savage ed Elisabeth Bumiller, “Un massacro iracheno, una condanna leggera e una questione di giustizia militare”, New York Times, 27 gennaio 2012; Josh White, “Soldato viene condannato a 90 anni di stupro e uccisione di una ragazza”, Washington Post, 17 novembre 2006; e Michael Safi, “Trump perdona gli appaltatori della Blackwater incarcerati per il massacro di civili iracheni”, Guardian, 23 dicembre 2020.
- ↩ Questo punto importante è abilmente espresso in David Vine, The United States of War: A Global History of America’s Endless Conflicts, From Columbus to the Islamic State (Oakland: University of California Press, 2020).
- ↩ David Michael Smith, Olocausti infiniti: morte di massa nella storia dell’impero degli Stati Uniti (New York: Monthly Review Press, 2023).
- ↩ Sabri Zain, “L’attacco degli Stati Uniti a Kuala Batu”, in Sejarah Melayu: A History of the Malay Peninsula, sabrizain.org/malaya, citato in Endless Holocausts, 377n86; Amy Greenberg, Una guerra malvagia: Polk, Clay, Lincoln e l’invasione del Messico del 1846 (New York: Vintage, 2012), 170–71, 210–11, 223; Richard C. Paddock, “Gli Stati Uniti si preparano a restituire le campane filippine che una volta suonavano per celebrare un massacro”, New York Times, 13 agosto 2018; Edwidge Danticat, “La lunga eredità dell’occupazione ad Haiti”, New Yorker, 28 luglio 2015; “G.I.’s Tell of a U.S. Massacre in Korean War”, New York Times, 30 settembre 1999; Shaun Raviv, “I fantasmi del mio Lai”, Smithsonian Magazine (gennaio 2018); e Michael Parenti, To Kill a Nation: The Attack on Yugoslavia (Londra: Verso, 2000), 120.
- ↩ Herman Knell, To Destroy a City: Strategic Bombing and Its Human Consequences in World War II (Cambridge, Massachusetts: Da Capo, 2003), 1, 334, citato in Endless Holocausts, 396n411.
- ↩ Micheal Clodfelter, Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Encyclopedia of Casualty and Other Figures, 1494-2007, 3a ed. (Jefferson, North Carolina: McFarlane and Company, 2008), 559-60, citato in Endless Holocausts, 397n414.
- ↩ Martin Luther King Jr., “A Testament of Hope” (1968), in A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King, Jr., a cura di James Melvin Washington (New York: HarperCollins, 1986), 315.
- ↩ King, “Un testamento di speranza”.












