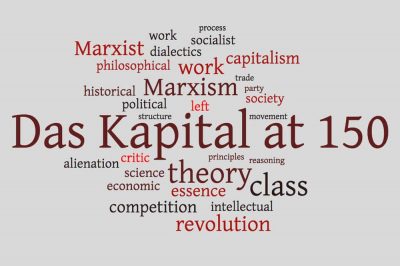Issac Deutscher 1 dicembre 1967
Le condizioni in cui un giovane intellettuale polacco studiava Das Kapital negli anni ’20 o ’30 erano molto diverse da quelle prevalenti nella maggior parte dei paesi occidentali. Per noi la previsione marxista del crollo del capitalismo non era una visione apocalittica legata solo lontanamente alle realtà della nostra vita quotidiana. Il vecchio ordine sociale si stava sgretolando sotto i nostri occhi. Questo era il fatto schiacciante della nostra esistenza. Non potevamo sfuggirgli. La mia infanzia e la mia adolescenza ne sono state scosse più e più volte. Sono cresciuto a Cracovia e in una piccola città a metà strada tra Cracovia e Auschwitz, su una punta di terra incuneata tra le frontiere di tre imperi. Da ragazzo di dieci e undici anni ho assistito alla caduta delle dinastie dei Romanov, degli Asburgo e degli Hohenzollern. Da un giorno all’altro svanirono gli antichi poteri, le santità e i feticci che avevano tenuto in soggezione il nostro popolo per molte generazioni. Abbiamo sentito l’alito caldo della Rivoluzione Russa. Poi, appena oltre la frontiera, la Comune di Budapest divampò e fu sommersa dal sangue.
A 13 anni ho assorbito dagli adulti lo stato d’animo teso con cui guardavano le notizie dell’avanzata dell’Armata Rossa su Varsavia. Per anni abbiamo vissuto quasi costantemente sull’orlo della guerra civile, tra inflazione galoppante, disoccupazione di massa, pogrom, rivoluzioni abortite e inutili controrivoluzioni. Ma anche prima di questi cataclismi, nella remota e spuriamente idilliaca era precedente al 1914, il marxismo era stato, dalle nostre parti, l’ideologia accettata di quasi tutto il movimento operaio. I nostri socialdemocratici di destra, non meno dei nostri comunisti, consideravano ancora il Capitale come la “Bibbia della classe operaia”, come la vecchia Bibbia, polverosa e non letta, ma venerata. I ritratti di Marx e Lassalle ci fissavano dal muro di ogni sindacato, organizzazione giovanile locale e socialista e persino di molti club sionisti. Ho avuto il mio primo sentore di materialismo storico da compagni di scuola più grandi; e anche se la mia educazione borghese ed ebraica ortodossa mi inclinava verso di essa, la traballanza della nostra esistenza sociale mi rendeva riluttante ad alcune delle idee rivoluzionarie che si respiravano nell’aria.
Ho provato a leggere Das Kapital nella tarda adolescenza, ma non ho perseverato. Mi sembrava una noce troppo dura da rompere, e non ero molto interessato all’economia politica. Avevo iniziato precocemente come poeta e critico letterario, ed ero alla ricerca di un approccio filosofico all’arte. Ero quindi interessato soprattutto alle grandi linee della Weltanschauung marxista.Allontanandomi dal Capitale, ho cercato di coglierli dalle opere minori di Marx ed Engels e dagli scritti di Plekhanov, Lenin, Mehring, Bucharin e altri. Ma le loro teorie filosofiche rimandavano sempre alle realtà socio-economiche alla base delle molteplici forme di coscienza umana.
E così mi sono ritrovato a scrutare di nuovo Das Kapital e a ingoiare esposizioni più popolari della sua dottrina economica. Li trovai abbastanza convincenti, e sentii che mi preparavano abbastanza adeguatamente per il futuro lavoro letterario e filosofico e per la lotta politica. È stato anche con una punta di irritazione che ho letto l’avvertimento di Marx in una delle sue prefazioni a Das Kapital che la scienza non conosce strade diritte e larghe e che “solo coloro che non schivano la fatica di salire sui suoi ripidi sentieri hanno la possibilità di raggiungere le sue vette chiare”. Mi chiesi se Marx non avesse reso quei sentieri un po’ troppo ripidi. A volte le sue sottigliezze dialettiche mi sembravano un po’ troppo elaborate in modo antiquato, e mi chiedevo quanto fossero rilevanti. La sua esposizione mi sembrava troppo lenta e rilassata per uno come me, impaziente di capire il mondo e di cambiarlo in fretta. Mi ha sollevato sentire che Ignacy Daszynski, il nostro famoso deputato, un pioniere del socialismo, un oratore sulle cui labbra pendevano i parlamenti di Vienna e di Varsavia, ha ammesso che anche lui trovava Das Kapital un osso troppo duro. «Io non l’ho letto», quasi si vantava, «ma Karl Kautsky l’ha letto e ne ha scritto un riassunto popolare. Nemmeno io ho letto Kautsky, ma Kelles-Krauz, il nostro teorico del partito, l’ha letto e ha riassunto il libro di Kautsky. Non ho letto nemmeno Kelles-Krauz; ma l’intelligente ebreo Herman Diamond, il nostro esperto finanziario, ha letto Kelles-Krauz e mi ha raccontato tutto”. A differenza del grande Daszynski, avevo almeno letto Kautsky e una miriade di altri divulgatori.
Nel frattempo mi ero impegnato politicamente: mi ero iscritto al Partito Comunista fuorilegge. Per anni sono stato occupato a dirigere riviste letterarie, a scrivere commenti politici, manifesti e volantini illegali, a rivolgermi agli operai, a organizzare anche i contadini, a condurre, come soldato, propaganda clandestina nell’esercito di Piłsudski, e per tutto il tempo a schivare la gendarmeria e la polizia politica. In queste circostanze non potevo nemmeno sognare di affrontare seriamente Das Kapital.
Il momento arrivò qualche anno dopo, nel 1932, quando fui espulso dal partito come portavoce di un’opposizione antistalinista. Sentivo il bisogno di riesaminare il mio pensiero politico e i principi del comunismo e del marxismo. Ho deciso di non dare nulla per scontato. La politica e le pratiche staliniste possono essere giustificate in termini di marxismo? L’analisi e la critica del capitalismo di Marx hanno resistito agli eventi del nostro tempo? Queste erano le domande che mi turbavano. Decisi di sfogliare tutto il Capitale, tutti e tre i suoi volumi, e anche i molti volumi Theorien über den Mehrwert, la storia delle dottrine economiche di Marx. Ero determinato a scrutare l’intera struttura intellettuale con freddezza e scetticismo, tenendo gli occhi aperti sui suoi possibili difetti e crepe. L’esprit de contradiction si impadronì di me; in alcuni momenti ero quasi deciso a dimostrare che Marx aveva torto. Forse a causa di questo intenso coinvolgimento o a causa della mia maggiore maturità intellettuale, questa volta non trovai affatto proibitivi “i sentieri ripidi”.
Nei tre o quattro anni successivi lessi e rilessi la grande opera nella sua interezza cinque o sei volte. Mi sono anche immerso nella vasta letteratura economica a cui Marx si riferiva; studiò i suoi critici borghesi, accademici e socialdemocratici; e mi sono familiarizzato con le diverse interpretazioni e sviluppi del Capitale offerti da Kautsky, Lenin, Hilferding, Luxemburg, Bucharin e altri. Mi ero lasciato alle spalle il mio punto di partenza, la poesia e l’estetica, e avevo investito tutte le mie passioni intellettuali nelle dottrine monetarie, nel ciclo commerciale, nella rendita fondiaria, nella concentrazione del capitale nell’agricoltura, nel calo del tasso di profitto, nell’impoverimento della classe operaia e in altri aspetti della triste scienza. Dalle esplorazioni di Ricardo, Sismondi, Sombart, Bohm-Bawerk e del primo Keynes, sono tornato più e più volte a Das Kapital e sono rimasto sempre di nuovo affascinato dalla ricchezza della sua trama teorica e storica e dalla chiarezza cristallina dell’analisi. La fatica della salita si è trasformata in pura eccitazione. Non dimenticherò mai l’emozione con cui dall'”alto” guardavo allora gli orizzonti sconfinati sulla società che Marx, sentivo, mi apriva davanti. Nessun’altra opera mi ha mai impressionato con una forza paragonabile.
Ma che dire di quei difetti che avevo cercato? Per quanto ci abbia provato, non sono riuscito a rilevarli. Ogni volta che rileggevo l’opera, la trovavo più rigorosamente argomentata e più convincente di quanto avessi pensato. Ho visto dove, nel capitolo iniziale, si poteva dissentire da Marx e seguire i teorici dell’utilità marginale. Questa teoria, tuttavia, non mi soddisfaceva: non potevo accettarla come alternativa alle concezioni marxiane del valore, della merce e del lavoro. E una volta accettate le sue premesse, non ho potuto fare a meno di seguirlo fino alle sue conclusioni.
Ero consapevole che Marx analizzava il capitalismo nella sua “forma pura”, come il chimico analizza i suoi elementi, mentre in realtà il capitalismo ha assorbito e porta in sé il relitto di tutti gli ordini sociali precedenti. Eppure nessuno lo sottolinea con più enfasi di Marx stesso, e nessuno ha chiarito le complessità strutturali della nostra società con qualcosa che si avvicini al suo realismo storico. E’ vero che egli si occupò del laissez-faire e non delle successive forme quasi monopolistiche di organizzazione capitalistica. Questo, riflettevo, non rendeva obsoleta la sua analisi, perché egli mostra precisamente come le forme monopolistiche nascano dal laissez-faire; E rivela, come nessun altro, la connessione organica tra queste fasi dello sviluppo economico. Già nella Miseria della filosofia, pubblicato 20 anni prima del Capitale, mentre si opponeva all’idealizzazione della libera concorrenza di Proudhon, dimostrava come la libera concorrenza tendesse al monopolio, il suo opposto dialettico. Poi, in Das Kapital, ha estrapolato drammaticamente il processo di concentrazione del capitale per descrivere la “tendenza storica dell’accumulazione” che porta all’espropriazione di molti imprenditori da parte di un numero sempre minore di “magnati del capitalismo”. Anche quando, per amor di discussione, egli ipotizzava una concorrenza perfetta, lo faceva solo per dimostrare che tale concorrenza era necessariamente autodistruttiva. E così non ho potuto (e non posso ancora) fare a meno di rimanere perplesso da quei suoi critici accademici che sostengono che Marx non era consapevole della “concorrenza imperfetta” del nostro tempo. In verità, tutti i trattati successivi sul capitale monopolistico, non marxisti e marxisti, compresi quelli di Hilferding e Lenin, non sono che esempi del modo in cui l’evoluzione economica ha confermato su questo punto le previsioni di Marx.
Ancora più importante, Marx mostra come, in relazione ai lavoratori, anche il capitalismo laissez-faire non sia mai stato altro che monopolistico. Non c’è mai stata né ci potrà essere una concorrenza perfetta tra capitale e lavoro, perché anche nel sistema salariale più “giusto”, in condizioni di scambio ideale di equivalenti tra datore di lavoro e lavoratore, solo il capitale è al comando dei mezzi di produzione; e solo essa si appropria del plusvalore. Finché è così, concludevo, la teoria di Marx non può essere superata, non importa quanto possano essere modificate le caratteristiche secondarie dell’ordine sociale.
Anche a quel tempo, 30 o 35 anni fa, vedevo l’essenza della teoria di Marx, non in questo o quell’aspetto della sua analisi del ciclo commerciale, e nemmeno nelle sue opinioni sull’impoverimento, relativo o assoluto, della classe operaia, per quanto queste opinioni fossero politicamente importanti. Certo, ha lasciato alcune questioni irrisolte e alcune questioni in sospeso. Ma per me l’essenza della sua analisi sta in ciò che dice sulla contraddizione centrale del nostro sistema sociale, il conflitto tra il processo di produzione socializzato e il carattere antisociale del controllo che la proprietà capitalistica esercita su questo processo. Inerente a ciò è l’estraniazione dell’operaio dal proprio lavoro, dai prodotti del suo lavoro e dalla struttura della società che il suo lavoro perpetua. Il nostro “stato assistenziale” ha a prima vista attenuato questo estraniamento, ma solo approfondendolo: e ha crudelmente aggravato l’alienazione del singolo lavoratore dagli altri lavoratori, cioè dalla sua stessa classe.
Lo studio del Capitale non solo mi ha confermato nella mia convinzione marxista e nel senso della sua incompatibilità con la natura di tartaruga del riformismo socialdemocratico; mi rivelò anche tutta la profondità dell’abisso che c’era tra il marxismo classico e le ciniche convenienze, la noiosa scolastica e i metodi inquisitoriali dello stalinismo. Da allora, mi è sembrato incongruo incolpare Marx per Stalin come lo sarebbe incolpare la Bibbia e Aristotele per i dogmi della Chiesa medievale e dell’Inquisizione. Fu come marxista che continuai ad oppormi allo stalinismo.
All’inizio lentamente, ma poi irresistibilmente, sono rimasto estasiato dallo stile di Das Kapital. Ha stabilito quello che è rimasto ai miei occhi il più alto standard di ragionamento e di espressione, uno standard che nessuno dei suoi discepoli, nemmeno il più grande, ha mai raggiunto. Pur rendendomi conto che sarebbe stato ingiusto applicare questo criterio ad altri pensatori e scrittori, Das Kapital sembra avermi lasciato qualcosa di simile a un’accresciuta sensibilità per lo stile di tutti i ragionamenti sui problemi sociali e politici. Pensavo di poter riconoscere la qualità di qualsiasi affermazione socialista o comunista dal suo linguaggio e dalla sua forma. Per molto tempo è stato il mio senso estetico ad essere offeso per primo da qualsiasi pezzo di marxismo contraffatto o fasullo; solo dopo di ciò procederei ad esaminarne il contenuto politico, filosofico o economico.
Ancora adesso è di solito una sorta di disagio estetico che mi mette in guardia da qualsiasi pretenziosa argomentazione pseudo-marxista. Provo spesso questo disagio quando seguo i dibattiti alla moda tra meta-marxisti, para-marxisti, esistenzialisti e strutturalisti su temi come l’alienazione, il Marx giovane e maturo, l'”umanizzazione” del marxismo e le categorie della ragione dialettica.
Leggendo Il capitale, mi sono reso conto del motivo per cui il suo autore non si è mai preoccupato di offrire ai suoi lettori un’esposizione sistematica dei principi della dialettica, anche se occasionalmente minacciava di farlo. Evidentemente preferiva applicare questi princìpi piuttosto che esporli; e quanto aveva ragione. Il fatto è che i tentativi di formulare le regole della dialettica di solito sfociano in un’arida scolastica. La dialettica è infatti la grammatica del pensiero marxista. Ma come si dimostra padronanza della grammatica non nel recitarne le regole, ma nel parlare in modo vivo, così si dimostra la propria padronanza della dialettica non rimuginando sulle sue formule, ma affrontando questioni specifiche, ampie e vitali della storia e degli affari contemporanei. Non c’è dubbio che le regole della dialettica devono essere apprese; Un buon manuale, come un buon libro di grammatica, ha i suoi usi. Ma la preoccupazione unilaterale per la metodologia astratta è spesso una forma di evasione ideologica, anche se coloro che vi indulgono amano soffermarsi su Praxis e scrivere Praxis con la “p” maiuscola. Das Kapital è l’esempio supremo della mente dialettica in azione, della mente dialettica che usa tutto il suo potere di astrazione per arare strato dopo strato l’esperienza sociale empirica.
Marx era, naturalmente, molto interessato anche ai problemi della sua bottega filosofica e alla natura dei suoi strumenti intellettuali, quelli che aveva ereditato da altri e quelli che lui stesso aveva inventato. Ma l’officina e gli strumenti non erano fini a se stessi: erano lì per lavorare la materia prima economica e socio-politica e per produrre il prodotto finito.
Ultimo ma non meno importante, Das Kapital è stato per me un’esperienza artistica memorabile. Mi resi conto che, come poche altre scoperte epocali, era il risultato non solo di un ragionamento rigoroso e di una ricerca eroica, ma di un’immaginazione creativa che aveva sfruttato il ragionamento e la ricerca per uno dei suoi tremendi salti. Nella scienza, tali salti hanno prodotto nuove visioni dell’universo, della struttura della materia, dell’emergere e della crescita delle specie. Copernico, Newton, Darwin ed Einstein, ognuno di loro deve essere stato dotato di una straordinaria capacità di creazione di immagini per essere in grado di vedere il mondo in una forma, una prospettiva e una luce sorprendentemente nuove, nascoste ai predecessori e ai contemporanei. Un genio artistico ritirato viveva in ognuno di questi giganti della scienza. Lo stesso, credo, vale per Marx. In quale altro modo sarebbe stato in grado di concentrare i suoi pensieri e le sue idee su quell’immagine del passato della società e su quella visione del suo futuro che da allora hanno ispirato una parte dell’umanità e ne hanno perseguitata un’altra?
L’arte di Marx è più direttamente evidente nell’architettura massiccia e classicamente pura del Capitale, nella forza e nella duttilità del suo linguaggio, nel suo grave pathos drammatico, nella sua satira e nel suo immaginario. So che ciò che sto dicendo può sconcertare coloro che hanno cercato di affrontare Das Kapital nella traduzione inglese e hanno trovato la sua prosa complicata e macchinosa. Una volta ho avuto un’esperienza simile con Shakespeare, che ho letto per la prima volta in miserabili traduzioni polacche. Solo dopo aver imparato l’inglese e aver ascoltato i suoi versi pronunciati sul palcoscenico inglese, ho ceduto alla piena forza della sua poesia. Wer den Dichter will uerstehen, muss im Dichters Lande gehen. Sfortunatamente, lo stile e il linguaggio di Marx non possono essere facilmente anglicizzati, anche se le traduzioni esistenti sono molto più goffe e rigide di quanto avrebbero dovuto essere.
Per quanto riguarda i meriti dell’originale, vorrei ricordare che Franz Mehring, critico letterario esigente (e acerrimo avversario di Marx prima di diventare suo seguace), dedicò un saggio speciale alla qualità poetica della scrittura di Marx. Ha analizzato le similitudini e le metafore di Das Kapital, sottolineandone la rara combinazione di inventiva immaginativa e precisione concettuale; e trovò un parallelo per loro solo nelle metafore e nelle similitudini di Goethe. Per un critico letterario tedesco questo era, naturalmente, il tributo supremo.
Un’ultima osservazione: per oltre 30 anni, dopo aver studiato Das Kapital, non ci sono più tornato. Durante tutto questo tempo mi sono limitato a dare un’occhiata alle sue pagine in alcune rarissime occasioni. Di recente, ho ricominciato a leggerlo perché mi ero impegnato a scrivere uno studio completo su Das Kapital. Finora ho passato in rassegna i primi tre capitoli, quelli ritenuti eccezionalmente coinvolti e astrusi – lo stesso Marx si è un po’ scusato per il loro stile “astratto ed hegeliano”. Mi ritrovo ancora affascinato dalle vecchie pagine familiari; Ma ciò che mi colpisce di loro ora, come non lo era mai stato prima, è la loro essenziale semplicità.
(Copyright © mondiale di Tamara Deutscher)1967, Volume 19, Numero 07 (Dicembre 1967)