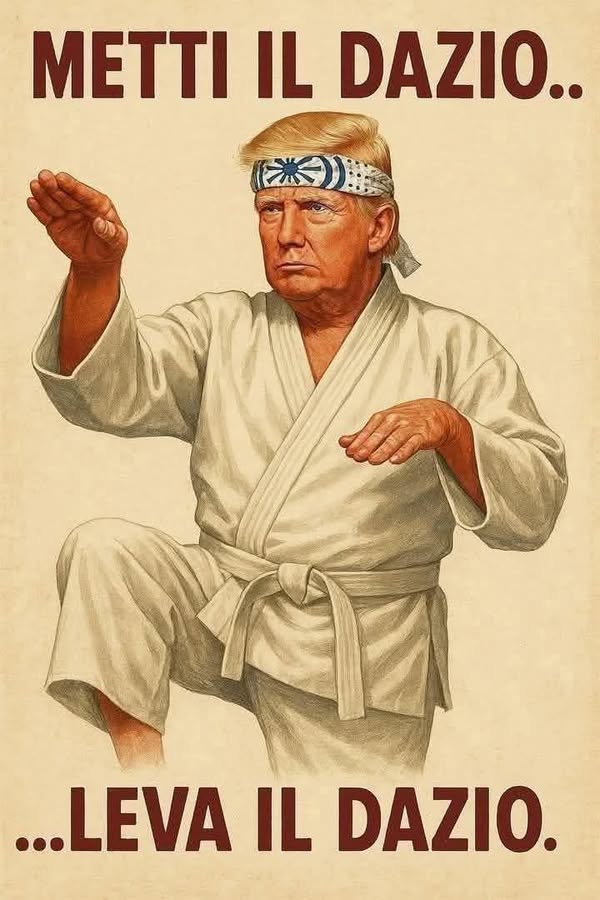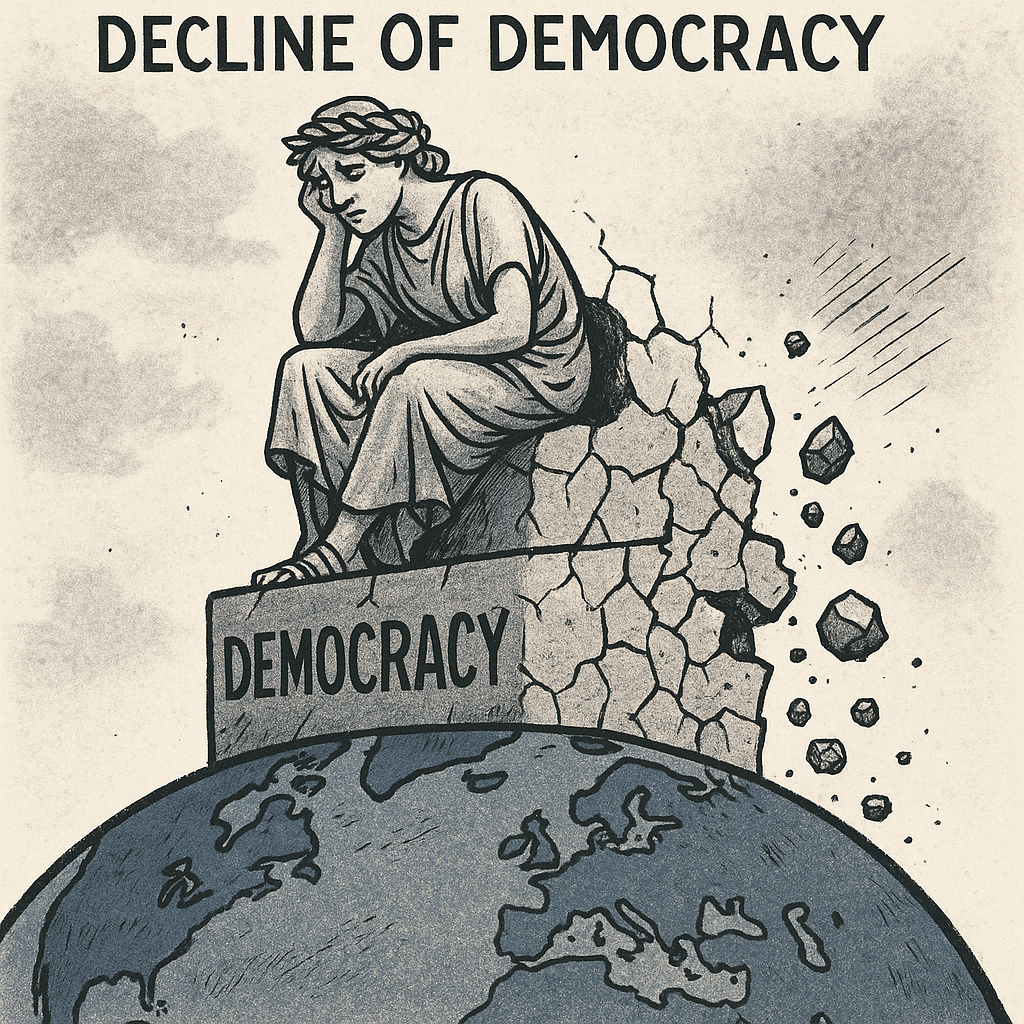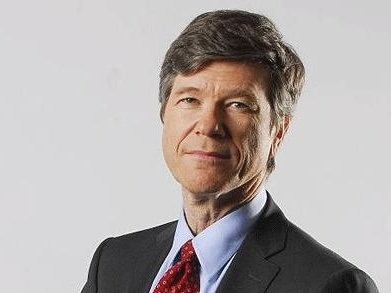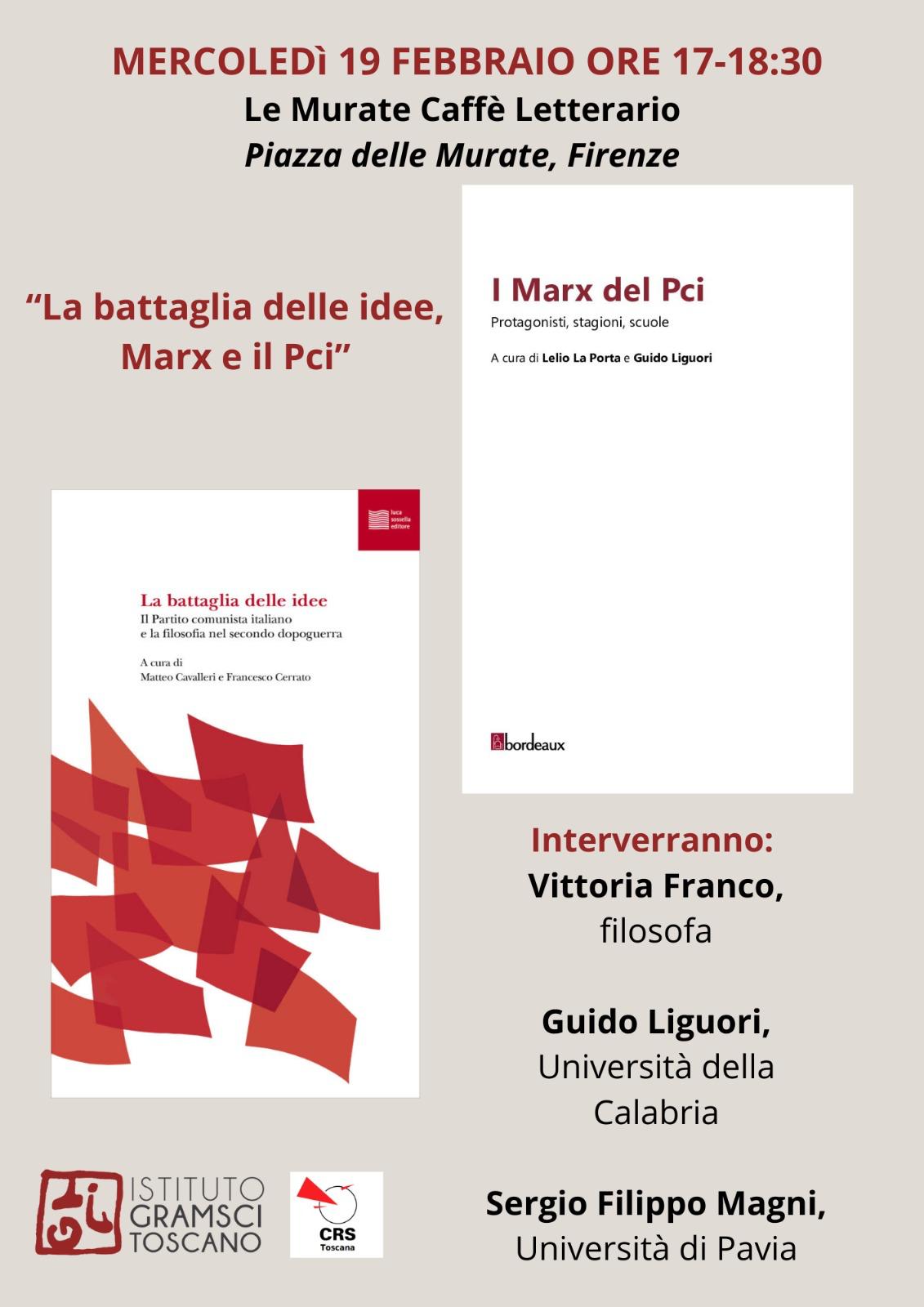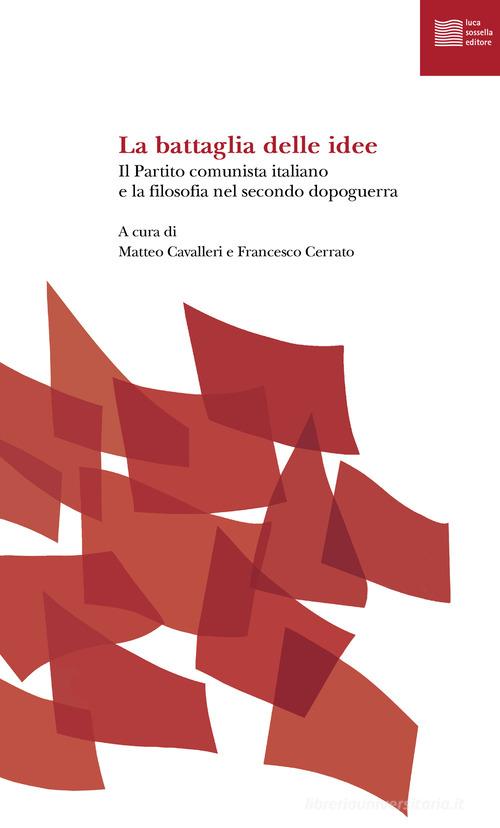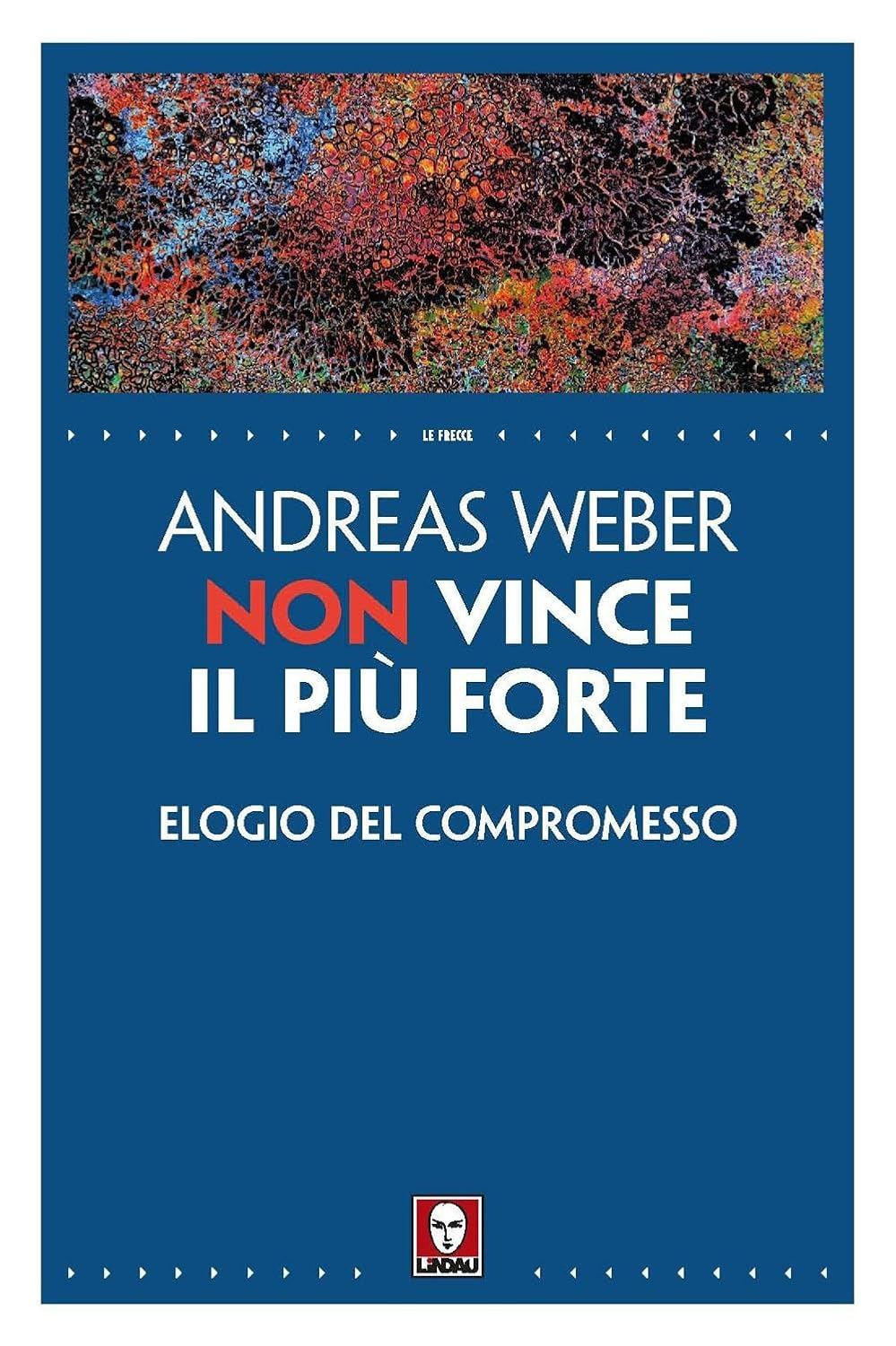di Maurizio Novelli*
SINTESI del saggio “Il vero piano di Trump” di Maurizio Novelli pubblicata su Sinistrainrete il 18-4-25
LINK AL TESTO SU SINISTRAINRETE
📘 Presentazione del saggio
Nel saggio “Il vero piano di Trump”, l’analista finanziario Maurizio Novelli esplora la trasformazione in corso nella politica economica e finanziaria statunitense, prefigurando una strategia radicale dell’amministrazione Trump per “mettere in sicurezza” un’economia americana che, secondo l’autore, si trova sull’orlo della bancarotta.
Attraverso un’analisi documentata e volutamente fuori dalla narrazione mainstream, Novelli descrive il tentativo di Trump di ristrutturare il sistema finanziario globale partendo da cinque pilastri fondamentali:
- Svalutazione del dollaro
- Controllo strategico della supply chain
- Amministrazione dei tassi d’interesse
- Riduzione dei costi energetici
- Uso di dazi e sanzioni come leva di pressione internazionale
L’articolo mette in luce il ruolo crescente del Tesoro USA rispetto alla Federal Reserve, la crescita anomala del settore dello Shadow Banking, l’utilizzo dell’Exchange Stabilisation Fund e l’uso dei Century Bonds come nuova forma di finanziamento pubblico.
L’autore fa riferimento al documento strategico “A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System” di Stephen Miran, illustrando come le politiche di Trump siano parte di un piano globale di salvataggio che intende riscrivere le regole del commercio, della finanza e delle relazioni geopolitiche.
🧠 Analisi critica e sintetica
1. Verso un “Trump Standard”?
Il cuore del saggio è la descrizione di una strategia sistemica che mira a modificare l’architettura del sistema finanziario globale: dalla riforma della Fed alla gestione della curva dei tassi d’interesse, fino all’introduzione di un nuovo regime di cambi fissi ancorato al dollaro. Il piano ipotizzato sembra voler salvare l’attuale ordine (Bretton Woods II) attraverso controllo, manipolazione e redistribuzione del rischio globale, piuttosto che tramite liberalizzazione.
2. Ruolo centrale del Tesoro USA
L’erosione delle funzioni della Federal Reserve a vantaggio del Tesoro segna un cambio paradigmatico nella governance economica americana: Powell, secondo Novelli, è ormai subordinato a Kevin Hassett sul piano della vigilanza bancaria. La gestione dei tassi a lunga scadenza viene descritta come ormai “amministrata”, introducendo un vero e proprio controllo statale del mercato obbligazionario.
3. La trappola dello Shadow Banking
Il saggio denuncia con forza la crescente esposizione al rischio “fuori bilancio” tramite veicoli opachi come Private Equity e Private Credit. Come nel 2008, gli attivi tossici vengono nascosti in circuiti non regolati, mettendo a rischio la trasparenza e la solidità del sistema finanziario.
4. Geopolitica dei dazi e della moneta
Novelli evidenzia come i dazi non siano solo protezionismo commerciale, ma una leva per ottenere un accordo sulla svalutazione competitiva del dollaro. L’analisi coglie il cambio di approccio: da negoziati multilaterali a misure coercitive unilaterali, rivelando l’isolazionismo aggressivo dell’amministrazione Trump.
5. Century Bonds e mutualizzazione dei costi
L’idea dei bond secolari riservati alle banche centrali alleate è una mossa per assicurarsi liquidità a basso costo e lungo termine, in cambio della continuazione della protezione militare USA. È un tentativo di trasferire parte del peso del debito americano su un sistema multilaterale basato su rapporti di forza.
6. La nuova rotta energetica e il riavvicinamento alla Russia
Una parte suggestiva ma controversa riguarda il presunto riposizionamento verso la Russia, motivato dall’interesse americano a far rientrare petrolio russo sul mercato per abbassare i costi dell’energia. In questa prospettiva, l’abbandono dell’Ucraina sarebbe una conseguenza economica più che geopolitica.
7. La Cina come partner (condizionato)
Secondo Novelli, la Cina potrebbe accettare l’accordo globale per proteggere le sue riserve e la stabilità interna, a patto che gli Stati Uniti riconoscano la sovranità cinese su Taiwan. In cambio, Pechino avvierebbe un programma di stimoli interni per espandere la sua influenza regionale.
🔚 Conclusioni
Il saggio offre una visione coerente, radicale e anti-convenzionale del progetto economico e geopolitico statunitense post-2024. Pur assumendo una posizione fortemente critica verso la narrazione mainstream, il lavoro di Novelli ha il merito di mettere in discussione i dogmi del libero mercato, dell’indipendenza delle banche centrali e dell’ordine multilaterale.
Sebbene alcune ipotesi siano speculative e discutibili (come l’automatismo del riavvicinamento USA-Russia o l’accettazione cinese su Taiwan), il testo funziona come provocazione intellettuale e strumento utile per leggere i segnali deboli dell’economia globale.
======================
I debiti americani che Trump vuol far pagare al mondo / di Piero Orteca
FONTE REMOCONTRO 28 Gennaio 2025
I debiti americani che Trump vuol far pagare al mondo
Il primo a denunciarlo fu Charles de Gaulle: «gli americani vivono al di sopra di quanto producono, a spese del resto del Mondo, meno ricco di loro». La bilancia dei pagamenti Usa è in cronico disavanzo dagli anni Settanta. Nel 2024 il deficit ha sfiorato il trilione di dollari (prossimi all’85% del Pil). Le passività americane possedute dall’estero (depositi, prestiti, titoli, azioni) si è retto sull’accettazione del dollaro strumento di transazione e di riserva internazionale. Autarchia e protezionismo di Trump la cura giusta?
Le nuove guerre nei mercati finanziari
Ormai lo ripetiamo da un pezzo: le nuove guerre dell’era Trump, saranno combattute nei mercati finanziari. E le vittime, innumerevoli, verranno sotterrate da sanguinose risse commerciali e assalti all’arma bianca, fatti di dazi e tariffe doganali. Sarà un calderone granguignolesco, dove un risorgente protezionismo soffocherà quello che resta della globalizzazione. Inutile farsi illusioni.
La perduta ‘Età dell’oro’
Il nuovo Presidente americano è stato chiaro nel suo primo discorso, all’atto dell’insediamento. «Trump – come scrive il Wall Street Journal – ha paragonato il suo approccio a quello di un altro Presidente, William McKinley, un leader repubblicano durante un’epoca nota come ‘Gilded Age’. Un periodo di rapida industrializzazione dopo la guerra civile, che creò un’enorme ricchezza per gli Usa, ma fu caratterizzato da una dilagante disuguaglianza». Tuttavia, il vero problema, che si trova davanti oggi il ‘sistema-America’, non è quello di una ricetta che resusciti una specie di autarchia del Terzo millennio. La questione è più profonda e riguarda l’etica stessa di un capitalismo malato. Di un modello, cioè, che mentre si dà delle regole, studia nello stesso tempo anche il modo per aggirarle. Perché il profitto non conosce ostacoli.
Fine del libero scambio
Dunque, Trump ha già deciso, con la sua squadra, di dare un colpo mortale ai principi del libero scambio. Attenzione: le sue ragioni sono squisitamente finanziarie e hanno la priorità. Quelle geopolitiche vengono solo dopo. Il nuovo Presidente ha già annunciato ulteriori tariffe del 10%, sulle importazioni in arrivo dalla Cina e, addirittura, del 25% sui prodotti canadesi e messicani. E qui dobbiamo aprire una larga parentesi, spiegando le ragioni di un simile approccio, che ricorda misure da emergenza bellica. E, in effetti, secondo i sacri libri di testo della teoria economica, gli Stati Uniti hanno un piede e mezzo nella fossa (finanziaria). Pensate, a novembre scorso (Amministrazione Biden) hanno battuto tutti i record di indebitamento pubblico, arrivando in rosso per la bazzecola di 37 mila miliardi di dollari. Come vanno avanti? Facendo debiti, cioè emettendo titoli di Stato. Danno carta (garantita, per carità) e ricevono soldi, che poi spendono. E diverse volte spandono. Ma questa è solo una parte del discorso. Perché, se l’economia non gira bene, se c’è inflazione o semplicemente se i risparmiatori ‘non si fidano’, allora bisogna alzare i tassi di interesse, e ripagare il debito costerà di più. Quindi, la situazione di «rosso cronico» è determinata da come va l’economia nel suo complesso.
Bilancia commerciale a colpi di dazi
In questo senso, un’importanza fondamentale hanno la bilancia commerciale e la differenza tra import ed export di beni, servizi e capitali. Bene, è questo il problema numero uno dell’America: di Biden, di Trump, o di chi volete voi. Stiamo parlando di una cifra che, alla fine del 2024, arrivava quasi a toccare i 1000 miliardi di dollari. Si può esportare di più, producendo bene e vendendo meglio, rendendo i prodotti competitivi grazie al rapporto prezzo-qualità. Oppure puoi scegliere la strada di Trump. Imponendo dazi doganali a casaccio, per proteggere i tuoi prodotti, anche se costano assai e, magari, sono fatti male. L’obiettivo è quello di costringere gli americani a comprare ‘Made in Usa’, delocalizzare con incentivi le fabbriche europee o di altri Paesi e, in ultima analisi, invertire a poco a poco il trend negativo della bilancia commerciale. Secondo alcuni economisti di scuola reaganiana, questo metterebbe in moto un circuito (noto agli specialisti come ‘curva di Laffer’) che preconizza un allargamento del volume del gettito fiscale, nonostante il taglio delle tasse. Insomma, il protezionismo all’estero consentirebbe all’Amministrazione repubblicana di cominciare a fare ‘campagna’ con due anni di anticipo, sulle elezioni di Mid term.
Privilegi da Stati Uniti d’America
D’altro canto, è questo il punto, non è che Trump debba preoccuparsi più di tanto del deficit federale. Se gli Usa si fossero chiamati in un altro modo, il Fondo monetario internazionale avrebbe già spedito i suoi ispettori a commissariare Ministeri e bilanci. La verità è che i conti dell’America sono allo scasso e non si procede al pignoramento perché la finanza internazionale è prigioniera del dollaro. Che vuol dire, che gli Usa possono fallire? No, ma ci marciano, come fa ora Trump. Il loro debito pubblico è la principale fonte di finanziamento valutario, grazie al dollaro, per il resto del mondo. Quasi tutte le transazioni avvengono in dollari, e chi cerca di farlo in qualche altra valuta è guardato di traverso.
In tempi non sospetti, Giscard d’Estaing, allora Ministro delle Finanze della Francia, disse che Washington godeva di questo “privilegio esorbitante”, che le consentiva di fare debiti, sapendo che qualcuno avrebbe comunque comprato il dollaro, indipendentemente dalle sue oscillazioni. Oggi, Trump non fa altro che approfittare, furbescamente, di un potere finanziario senza limiti, che il suprematismo americano ha saputo costruire nell’ultimo secolo. Ci sono molti modi di fare le guerre, anche senza dover sparare un colpo.